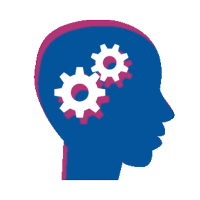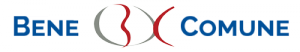«Ma la vera crisi dei nostri tempi, della mia generazione, non nasce dal fatto che non ce la passiamo bene, e nemmeno che potremmo stare peggio da qui in poi. No, la vera crisi è la nostra incapacità a tirare fuori qualcosa di meglio» (p. 17).
«Ma la vera crisi dei nostri tempi, della mia generazione, non nasce dal fatto che non ce la passiamo bene, e nemmeno che potremmo stare peggio da qui in poi. No, la vera crisi è la nostra incapacità a tirare fuori qualcosa di meglio» (p. 17).
Bregman è un giovane storico nato nel 1988, olandese, di solida formazione, grande capacità critica anche verso di sé e sufficientemente spregiudicato e non inquadrato nel pensiero dominante. In genere sono i giovani esploratori che aprono nuove strade, come accade nella ricerca matematica e fisica, per esempio. Bregman è uno di questi.
Le sue proposte non sono poi così fuori dal mondo, u-topiche: reddito minimo garantito per i poveri, riduzione delle ore lavorative settimanali, lavori utili al bene comune e non lavori “burla”, apertura delle frontiere ai migranti economici, maggiore tassazione dei patrimoni secondo quanto propone Piketty.
La bellezza e la novità di questo libro è che porta innumerevoli esempi storici di come queste proposte sono state già attuate in vari posti del mondo sia sviluppato che in via di sviluppo.
Bregman è convincente nelle sue proposte, perché ci crede ed è supportato da evidenze storiche, anche se è sufficientemente consapevole che il lavoro, soprattutto culturale, prima ancora che politico, è enorme perché il pensiero dominante è forte ed i suoi sostenitori sono determinati a sostenerlo fino in fondo.
E’ una battaglia che si svolgerà prima di tutto nelle menti delle persone, dei popoli, e poi nelle aule dei parlamenti e nei decreti dei governi.
Il primo capitolo fa una disanima di che cosa sia un’utopia e della sua forza per cambiare la visione del mondo in cui si è sviluppata. Potrebbe essere utile a questo proposito leggere anche il libro di Paolo Prodi e Massimo Cacciari, Occidente senza Utopie.
Il secondo è quello più controintuitivo: regalare dei soldi a chi non ne ha a sufficienza, ai poveri, senza contropartite è l’investimento migliore e più redditizio per tirarli fuori dalla loro miseria e precarietà.
Un esempio tra i tanti che Bregman propone. Nel marzo del 1973 il governatore della provincia di Manitoba, in Canada, decise di stanziare 83 milioni di dollari attuali per dare a 1.000 cittadini di Dauphin, su 13.000 abitanti, un reddito minimo, cioè un assegno mensile. Una famiglia di 4 persone riceveva l’equivalente attuale di 19.000 dollari all’anno senza altri requisiti. Il successo fu clamoroso. Di fronte al timore che con un reddito annuo garantito la gente avrebbe smesso di lavorare e avrebbe iniziato a fare più figli, i giovani posticiparono le nozze e la natalità crollò. I risultati scolastici migliorarono. Gli uomini lavorarono solo l’1% di ore in meno, le donne sposate restarono di più a casa dopo aver partorito e le studentesse studiarono di più. I ricoveri ospedalieri diminuirono del 8,5%. Inoltre calarono le violenze domestiche e i problemi di salute mentale. Un vero successo che il governatore successivo, conservatore non comprese e terminò l’esperimento.
Il terzo approfondisce la questione della disuguaglianza come fonte di povertà.
Il quarto è il racconto di come Nixon, repubblicano, sia stato a un passo dal creare un vero welfare state negli USA e di come si possa influenzare un presidente e un Congresso con dati volutamente falsificati, pur di sostenere le proprie convinzioni ideologiche, in questo caso false.
Il quinto è una disanima di come si costruiscono statistiche non tanto più vere, ma che critiche, nel senso di sapere cosa effettivamente mostrano o nascondono.
Il sesto è una prospettiva sul futuro del lavoro, che sarà sicuramente diverso da quello che abbiamo sotto gli occhi, in quanto già oggi molti chiedono di fare lavori veri, non “finti”, cioè che non hanno un vero senso per la costruzione del bene comune.
Il settimo presenta un’analisi di come il lavoro dei banchieri sia spesso una “burla”, cioè essi non creano ricchezza, ma solo la spostano a proprio vantaggio e a detrimento di coloro che ne avrebbero più bisogno. Inoltre mostra come moltissime persone fano lavori burla, tipo «addetto al telemarketing, direttore delle risorse umane, social media manager, consulente di pubbliche relazioni e una sequela di posizioni amministrative in ospedali, università e uffici». Secondo Bregman oggi i migliori cervelli si dedicano a lavori remunerati ma che nono sono quelli che producono «utilità, qualità e innovazione», tutte azioni che migliorano la vita comune: «Pensate come sarebbe se tutto questo talento fosse investito non nello spostamento della ricchezza, ma nella sua creazione. Chi lo sa, forse avremmo già i jet pack, avremmo già costruito le città sottomarine o trovato la cura per il cancro».
L’ottavo ragiona sul lavoro nell’epoca della rivoluzione tecnologica, sul come non essere luddisti e come poter affrontare un nuovo modo di essere lavoratori.
Il nono osserva come l’apertura delle frontiere agli immigrati economici porterebbe un guadagnano a tutti. Come mai le merci circolano ma i lavoratori no? Come riequilibrare tutto questo? (si chiede l’autore).
Il decimo è la disamina di come sia nato il pensiero dominante attuale in economia e di come la forza delle idee e la loro razionalità sia sufficiente per scalfire le convinzioni fate anche di emozioni e tanto altro.
L’epilogo di 9 pagine è folgorante e merita tutto il libro. Si parla di come perseguire concretamente questi obiettivi di civiltà.
C’è la politica come arte del possibile, come ha affermato Otto von Bismark, e la Politica che non parla di regole, ma di rivoluzione, non dell’arte del possibile, ma di come rendere inevitabile l’impossibile. Questa Politica è sempre stata ad appannaggio della sinistra, che però sembra averlo dimenticato, diventando il “socialismo perdente”. Il socialista perdente ha dimenticato che il vero problema non è il debito pubblico, ma le imprese e le famiglie sovraesposte ai rischi dell’economia, ha dimenticato che investire nella povertà è un investimento che ripaga con gli interessi.
Bregman vuole un nuovo movimento dei lavoratori «che combatta non solo per più posti e per stipendi più alti, ma soprattutto per un lavoro che abbia un valore intrinseco» (p. 212).
Per Bregman i socialisti perdenti devono smettere di «bearsi della loro superiorità morale e delle idee sorpassate […] In fin dei conti, quello che manca ai socialisti perdenti è l’ingrediente principale del cambiamento politico: la convinzione che c’è davvero una strada migliore. Che l’Utopia è a portata di mano».
Il libro si conclude con due consigli di Bregman.
«Per prima cosa, sappiate che là fuori ci sono tante persone come voi. Tantissime. Ho incontrato un’infinità di lettori che mi hanno detto che, per quanto non credano minimamente nelle idee di questo libro, hanno capito che il mondo è avido e corrotto. La risposta che davo loro era questa: spegnete la tv, guardatevi intorno e organizzatevi. Tantissima gente ha il cuore al posto giusto.
Secondo: vi consiglio di farvi una pelle più coriacea. Non permettete che nessuno vi insegni come vivere. Se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo essere irrealisti, poco ragionevoli e implausibili. Ricordate: anche quelli che invocavano l’abolizione dello schiavismo, il suffragio alle donne e il matrimonio fra persone dello stesso sesso erano etichettati un tempo come pazzi. Finché la storia ha dato loro ragione» (p. 214).
Parole saggie di un giovane impegnato a costruire un mondo migliore.
Bregman, R., Utopia per realisti. Come costruire davvero il mondo ideale, Feltrinelli, Milano 2017.
Citazioni
“I soldi gratis impoveriscono la gente. Peccato che non sia vero, almeno se stiamo alle prove” (p. 31).
“Questa iniziativa ha messo la scelta nelle mani dei poveri [..] Faye non dà il pesce alla gente, e nemmeno le insegna a pescare. Le dà dei soldi, nella convinzione che i veri esperti di quello che serve ai poveri siano i poveri stessi” (p. 31).
“Per tornare all’Università di Manchester, i suoi ricercatori hanno riassunto i vantaggi di questi programmi in questi termini: 1) le famiglie fanno buon uso dei soldi; 2) la povertà cala; 3) possono esserci svariati vantaggi a lungo termine quanto a reddito, salute ed entrate fiscali; e 4) questi programmi costano meno delle alternative. Perciò perché inviare quei costosi bianchi sui loro suv quando ci basta elargire i loro stipendi ai poveri?” (p. 33).
“La povertà è fondamentalmente una mancanza di contante” (p. 34).
“Andando al sodo, queste tasse (sulle transazioni finanziarie) ci renderebbero tutti più ricchi. Non solo darebbero a chiunque una fetta più equa della torta, ma la torta sarebbe più grande. E allora i genietti emigrati a Wall Street potrebbero diventare insegnanti, inventori e ingegneri.
“Negli ultimi decenni è successo l’esatto contrario. Una ricerca svolta ad Harvard ha scoperto che i tagli alle tasse dell’era Reagan favorirono una svolta di massa nelle carriere delle menti più brillanti del paese, da insegnanti e ingegneri a banchieri e commercialisti. Laddove nel 1970 il numero di laureati maschi a Harvard che sceglievano una vita dedicata alla ricerca era ancora il doppio di quelli che preferivano le banche, vent’anni dopo il rapporto s’era invertito, e gli ex allievi occupati nel settore finanziario erano una volta e mezzo più numerosi” (p. 139).
“Pertanto se c’è un posto in cui possiamo intervenire in modo che dia dividendi per la società negli anni, quello è l’aula scolastica […] L’interesse verte sulle competenze, non sui valori, Sulla didattica, non sugli ideali. Sulla “capacità di risoluzione dei problemi”, ma non su quali problemi bisogna risolvere. Ineluttabilmente tutto ruota attorno alla domanda: di quali competenze e conoscenze hanno bisogno gli studenti di oggi per essere assunti nel mercato del lavoro di domani, il mercato del 2030?”
“E’ esattamente la domanda sbagliata. […]
Invece dovremmo porre una domanda totalmente diversa: quale conoscenza e quali competenze vogliamo che abbiano i nostri figli nel 2030? In questo modo, invece di anticipare e adattarci, ci concentreremmo sulla direzione e sulla creazione. Invece di domandarci di che cosa abbiamo bisogno per sbarcare il unario con questo o quel lavoro burla, potremmo riflettere su come vogliamo sbarcare il lunario. E’ una domanda a cui non può rispondere nessun trend watcher. Come potrebbe? Loro seguono solo le tendenze, mica le fanno. Questa parte compete a noi” (pp. 140-141).
“I politologi hanno verificato che il voto delle persone non è determinato tanto dalle loro percezioni della propria vita, quanto dal loro concetto di società. Non siamo particolarmente interessati a quello che il governo può fare per noi personalmente, vogliamo sapere cosa può fare per tutti noi. Quando esprimiamo il nostro voto non lo facciamo solo per noi, bensì per il gruppo cui vogliamo appartenere” (p. 196).
“Ma il più grosso problema del socialista perdente non è che si sbaglia. Il suo più grosso problema è che è noioso. Barboso. Non ha una storia da raccontare, nemmeno un linguaggio per narrarla. […] Purtroppo il socialista perdente s’è scordato che la storia della sinistra dovrebbe essere una narrazione fatta di speranza e progresso […] Se non riesci a spiegare il tuo ideale a un dodicenne di intelligenza media, allora probabilmente è colpa tua” (p. 210).
“Riforme? Cavolo, sì. Diamo una bella ripassata al settore finanziario. Costringiamo le banche a mettere insieme ammortizzatori più grossi in modo che non vadano gambe all’aria appena arriva un’altra crisi. Facciamole a pezzetti, se proprio dobbiamo, in modo che la prossima volta ai contribuenti non resti da pagare il conto perché le banche sono “troppo grosse per fallire”. Smascheriamo e distruggiamo tutti i paradisi fiscali in modo che i ricchi possano finalmente essere costretti a sganciare la giusta parte e i loro commercialisti possano fare qualcosa di utile.
Meritocrazia? Ben venga. Paghiamo finalmente la gente in base al suo vero contributo. Netturbini, infermieri e insegnanti dovrebbero avere un aumento sostanzioso di stipendio, ovvio, mentre qualche lobbista, legale o banchiere vedrebbe crollare i propri emolumenti. Se volete svolgere un lavoro che danneggi il pubblico, fate pure. Però dovrete pagare per il privilegio con un’imposta più pesante.
Innovazione? Assolutamente. Ancora oggi va sprecata un’enorme quantità di talento. Se i laureati della Ivy League un tempo andavano a fare gli scienziati, i pubblici ufficiali e gli insegnanti, oggi è assai più probabile che scelgano banche, studi legali o incubatori di pubblicità come Google e Facebook. Fermatevi un momento a riflettere sui miliardi di dollari di tasse che vengono spesi per addestrare i migliori cervelli della società, tutto questo perché possano imparare a sfruttare gli altri nella maniera più efficiente possibile, e vedrete che vi girerà la testa. Immaginate come sarebbe diverso se i migliori della nostra generazione dovessero applicarsi alle massime sfide dei nostri tempi. Il cambiamento climatico, per esempio, e la popolazione che invecchia e la disuguaglianza… Questa sì che sarebbe vera innovazione.
Efficienza? É questo il punto. Pensateci: ogni dollaro investito in un senzatetto restituisce il triplo, se non di più, come risparmi nei costi di sanità, polizia e tribunale. Immaginate che cosa potrebbe ottenere l’eliminazione della povertà infantile. Risolvere questo tipo di problemi è parecchio più efficiente della loro “gestione”, che alla lunga costa molto di più.
Tagliare lo stato-mamma? Esatto. Sforbiciamo quegli insensati e arroganti corsi per il riavviamento di chi ha perso il lavoro (in particolare quelli che prolungano la disoccupazione) e smettiamola di addestrare e umiliare chi incassa un sussidio. Diamo a tutti un reddito di base, venture capital, capitale di rischio per il popolo, che ci permetta di tracciare la rotta della nostra vita.
Libertà? Puoi dirlo forte, sorella. Mentre siamo qui a parlare, fino a un terzo della forza lavoro è invischiato in “lavori burla” che sono considerati insensati dalle stesse persone che li svolgono. Non molto tempo fa ho parlato a qualche centinaio di consulenti sulla crescita dei lavori inutili. Con mio grande stupore non sono stato fischiato dal pubblico. Non solo, ma mentre alla fine bevevamo un goccio, più di una persona mi ha confessato che alcuni compiti ben pagati affidati a loro gli avevano dato in realtà la libertà finanziaria di fare qualcosa di meno remunerato ma più dignitoso.
“Queste storie mi hanno ricordato tutti i giornalisti freelance che sono stati risucchiati nella scrittura di pezzi promozionali per aziende che disprezzano soltanto per finanziare il proprio lavoro di indagine critica (esattamente sulle stesse aziende). Il mondo alla rovescia? A quanto pare, nel capitalismo moderno paghiamo le cose che troviamo sinceramente appaganti con… con le stronzate, le burle”.
“È venuto il momento di ripensare il nostro concetto di ‘lavoro’. Quando rivendico una settimana di lavoro più corta, non propongo lunghi fine settimana letargici. Propongo che passiamo più tempo sulle cose che contano davvero per noi. Qualche anno fa, la scrittrice australiana Bronnie Ware ha pubblicato un libro intitolato The Top Five Regrets of the Dying [Vorrei averlo fatto. I cinque rimpianti più grandi di chi è alla fine della vita], i primi cinque rimpianti dei moribondi che aveva accudito quando faceva l’infermiera. Indovinate un po’. Nessuno le aveva detto che avrebbe voluto prestare maggior attenzione alle presentazioni in PowerPoint dei colleghi o aver fatto più riunioni sulla creazione rivoluzionaria nella società in rete. Il loro più grosso rimpianto era: ‘Vorrei aver avuto il coraggio di vivere una vita vera per me, non la vita che gli altri si aspettavano da me’. Numero due: ‘Vorrei aver lavorato di meno’ “. (pp. 210-212).
Tags: Giovani Rivoluzione Utopia