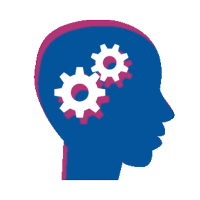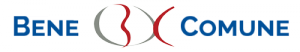Ernesto Laclau è un filosofo politico argentino, scomparso nel 2014. È stato un’intellettuale cosmopolita, probabilmente suo malgrado: nel 1969 fuggì in Inghilterra a seguito del golpe militare che portò al governo il generale Ongania. Ha insegnato per lo più in università anglofone, principalmente ad Essex. Riportiamo queste note biografiche perché ci paiono significative di due antecedenti fondamentali del suo pensiero. L’esperienza diretta di un governo autoritario ha, con molta probabilità, contribuito allo sviluppo dell’idea per la quale il populismo non è un’aberrazione politica, ma una delle forme che può assumere il politico. Vivere sotto una dittatura implica l’esigenza di spiegare, innanzitutto a sé stessi, come si sia potuti arrivare a una situazione del genere, quali forze abbiano operato e quali contrappesi non abbiano funzionato: una dittatura non è qualcosa di eccezionale, ma una piega che – a determinante condizioni – può essere assunta da qualsiasi situazione politica. Questa idea è espressa in modo inequivocabile nell’ultima pagina di La ragione populista: «possiamo cominciare a capire il fascismo solo se vi scorgiamo una delle tante possibilità delle società contemporanee, e non qualcosa che va oltre ogni spiegazione razionale» (p. 236).
La seconda nota biografica rilevante riguarda l’aver insegnato in ambiente anglosassone: lo stile argomentativo di Laclau è prettamente analitico, i concetti vengono definiti, fatti interagire tra loro, portati alle estreme conseguenze logiche. Molta teoria sociale contemporanea usa retoriche letterarie come l’analogia, l’assonanza, la metafora producendo seducenti costruzioni teoriche di dubbia utilità politica. Oppure si rifugia in categorie iper-generali (la globalizzazione e il neoliberismo sono le più usate) che si adattano a tutti i fenomeni, ma spiegano poco. Laclau non adotta nessuna delle due modalità argomentative. La costruzione della sua teoria sul populismo è rigorosa, conseguenziale, senza ellissi e salti logici: una volta accettate le premesse, le conseguenze sono naturali. Questo approccio rende la lettura ostica: La ragione populista è un libro difficile, ma allo stesso tempo affascinante perché il lettore attento e disposto al sacrificio, una volta fatto proprio il dispositivo teorico proposto da Laclau, si ritrova tra le mani delle potentissime chiavi interpretative per un fenomeno sfuggente come il populismo.
Rendere conto in una recensione di qualche pagina del tour de force teorico di La ragione populista è impossibile: l’invito è a studiare il libro, una semplice lettura potrebbe non essere sufficiente, con a portata di mano carta e penna. Per rendere il fascino di questa lettura vi proponiamo alcuni passaggi fondamentale dell’argomentazione di Laclau, provando ad attualizzarli tramite un confronto con la situazione politica italiana.
Verso la fine del capitolo 4, intitolato Il «popolo» e la produzione discorsiva del vuoto, Laclau scrive: “con «populismo» non ci riferiamo a un tipo di movimento — identificabile magari con una certa base sociale o un certo particolare orientamento ideologico —, ma ci riferiamo a una logica politica. Tutti i tentativi di scorgere ciò che è tipico del populismo in elementi come una base sociale di contadini o piccoli proprietari, oppure la resistenza alla modernizzazione economica, oppure la manipolazione da parte di élites, sono, come abbiamo visto, assai discutibili, perché sollevano una valanga di eccezioni” (p. 111).
Se non ha né una base sociale definita né un contenuto ideologico preciso come si forma un movimento populista? Innanzitutto, una parte di un popolo deve iniziare a considerarsi come il tutto del popolo, creando una frontiera all’interno del popolo stesso che esclude chi non fa parte di quella parte che si fa tutto. Nella situazione italiana, la ribellione contro la casta da parte della gente può essere considerata nei termini di una parte di popolo che arriva a considerarsi come il popolo. Questo slittamento si basa sulla costruzione di una frontiera politica. Nelle democrazie le domande sociali vengono soddisfatte in modo differenziale, ossia in maniera specifica e isolata. Per ogni categoria di domande le istituzioni producono risposte ad hoc: indennità di disoccupazione per chi non ha lavoro, agevolazioni fiscali per le imprese, asili nido per le famiglie con figli piccoli. Tuttavia, non tutte le domande sociali trovano una risposta, ce ne sono sempre alcune che rimangono insoddisfatte: ad esempio, la domanda di sicurezza nelle città o la questione dei prezzi delle produzioni agricole. Questi due esempi non sono presi a caso, ma riguardano due delle istanze fondamentali della proposta politica leghista. Come ha fatto Matteo Salvini a tenere assieme i cittadini impauriti e il contadino strozzato dal mercato?
Secondo Laclau in questa fase di costruzione del popolo opera un meccanismo discorsivo (chiamato “catena equivalenziale”) per il quale alla loro costitutiva eterogeneità si sostituisce l’idea che le domande sociali inascoltate siano equivalenti le une alle altre poiché si contrappongono tutte al potere che non le soddisfa. Abitanti delle periferie urbane e contadini hanno bisogni diversi, ma che si equivalgono perché entrambi non trovano risposta da parte delle élite. Così facendo il leader leghista può passare dal comizio in città all’assemblea di Coldiretti senza modificare poi di molto il suo canovaccio politico. Il fulcro del meccanismo è che le domande rimangono particolari, ma si equivalgono in quanto tutte sono caratterizzate da questa contrapposizione con il potere.
Per poter però raccogliere il più ampio spettro di domande sociali insoddisfatte c’è bisogno che il simbolo che unifica il popolo (Laclau usa correttamente il termine “significante”) sia vuoto: in altre parole, il simbolo deve essere il più possibile indeterminato così da contenere meglio istanze anche contraddittorie, poiché il suo scopo non è quello di soddisfare le domande sociali, in quanto è impossibile soddisfare tutti, ma mantenere quel tutto che è il popolo. È questo il motivo che rende così indecifrabili le proposte politiche del M5S: il movimento è il significante vuoto che costituisce il suo popolo raccogliendo al suo interno domande sociali differenti, ma che si equivalgono perché contrapposte a una stessa frontiera politica. Per questo motivo, il reddito di cittadinanza benché sia una misura differenziale è percepito come un intervento in continuità con la missione politica del M5S, ossia riportare il potere nelle mani del popolo decidendo in autonomia a chi dare i soldi dello stato, senza assecondare i richiami ai vincoli di bilancio provenienti dall’Europa perché il popolo per troppo tempo è stato vessato dalle élite burocratiche e tecnocratiche.
Un elemento fondamentale della teoria di Laclau è che il significante vuoto il quale costituisce il popolo non è dato una volta per tutte. Al fine di ricomprendere domande sociali distanti può essere spostato andando a creare una nuova frontiera politica (in virtù del suo dinamismo viene definito significante fluttuante). Salvini in un comizio a Cittadella nel 2015, come in tante altre occasioni, proponeva di usare le ruspe per spianare campi rom e centri sociali (l’accoppiata è un perfetto esempio di catena equivalenziale tra antiziganismo e anticomunismo), a tre anni di distanza il significante vuoto salviniano è fluttuato sino a ricomprendere prima l’immigrazione irregolare, poi l’immigrazione tutta, con lo slogan “chiudiamo i porti”. Di equivalenza in equivalenza, rom, comunisti, rifugiati politici e umanitari, migranti economici, sino ad arrivare a chiunque non sia italiano. In altre parole, ha riunito dentro uno stesso contenitore cose molto diverse fra loro.
Un altro esempio dello stesso Laclau aiuta a precisare la questione: all’indomani della caduta del Muro di Berlino, per molti Est-Europei il mercato non era solo una forma di organizzazione dell’economia, ma molto di più: un simbolo di libertà, una promessa di futuro. Allo stesso modo, l’immagine di un’Italia dove gli immigrati rigano dritto e se sbagliano vengono rispediti al loro paese, ricomprende anche l’idea di un Italia dove il benessere è diffuso, le coppie non divorziano, le donne stanno a casa al loro posto, un ideale tradizionale corrotto dall’inopinata presenza degli immigrati.
Ma cosa permette al popolo di convivere con le contraddizioni intrinseche alle catene equivalenziali? In poche parole, come fanno gli elettori della Lega a considerare tutti gli immigrati terroristi? La risposta più immediata sarebbe l’ideologia, la xenofobia e il razzismo. Sicuramente nel popolo di Salvini ci sono dei razzisti convinti, ma appare evidente che ci possano essere anche persone che non condividono appieno un’ideologia razzista: come fanno queste ultime a convivere con le prime? Nell’ipotesi, altamente probabile, che non tutti i leghisti siano razzisti, come si spiega la coesione del fronte politico salviniano? La risposta di Laclau è sorprendente: è una questione di affetti. Attraverso una raffinata declinazione politica della psicanalisi lacaniana (e un parallelismo fondamentale con il concetto gramsciano di egemonia), l’autore spiega come il populismo sia un investimento radicale, e quindi anche affettivo, in una parzialità che aspira a diventare una totalità: “non c’è populismo senza investimento affettivo in un oggetto parziale”. Il popolo è una pienezza non realizzata che desidera diventare tale: è questo investimento sentimentale che sostiene l’articolazione politica populista. Il passaggio concettuale non è semplice, tuttavia Laclau riporta un esempio che fa chiarezza. Nel cinema un primo piano su un volto non rappresenta un dettaglio di un’immagine più ampia (la figura intera): quando la macchina da presa stringe su un volto, la totalità della scena è riempita da quel volto.
L’attenzione dello spettatore è per la parte che si fa tutto, non per quanto rimane fuori dall’inquadratura. In questo senso, la logica del salvinismo punta a saturare la scena politica, a incorniciare la società lasciando fuori dal quadro tutto ciò che non è coerente con la propria immagine di comunità. Si tratta di una pulsione che è destinata a rimanere insoddisfatta perché sempre alla ricerca di nuovi oggetti: in questo modo la frontiera politica si sposta, espellendo di volta in volta nuovi soggetti sociali dalla comunità: i rom, i migranti, i comunisti, gli omosessuali e cosi via sino ad arrivare a categorie non meglio definite come i buonisti e i radical chic. L’oggetto della pulsione è una sorta di comunità immaginata, per usare la nota categoria di Benedict Anderson, omogenea e omologata, nella quale le differenze non sono ammesse e il cambiamento sociale assume la forma di una tradizione inventata. Se si guarda alla strategia comunicativa di Salvini, soprattutto al suo modo di stare sui social media, si riscontra un ricorrente riferimento a un’Italia che non c’è più perché forse non c’è mai stata: un idillio a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, quando eravamo tutti spensierati e fiduciosi, l’industria esportava e l’Italia contava, si faceva il presepe in ogni scuola, c’era solo la pasta Barilla e gli spagnoli non si erano comprati il ragù Star.
La ricostruzione che abbiamo proposto, pur nei limiti della sintesi, potrebbe lasciare intendere che non c’è via di scampo all’egemonia del populismo reazionario, tuttavia Laclau precisa che: “la costruzione di una catena equivalenziale a partire da una dispersione di domande frammentate e la loro unificazione attorno a posizioni popolari che operano come significanti vuoti non sono di per sé fenomeni totalitari, sono semmai i requisiti stessi per la costruzione di una volontà collettiva che, in tantissimi casi, può essere profondamente democratica” (p. 157).
Lo spazio a disposizione non ci consente di approfondire oltre la proposta di Laclau, ciò che comunque ci preme ribadire è come in questo volume – che ricordiamo è stato scritto nei primi anni del duemila – il teorico argentino fornisca degli strumenti concettuali fondamentali per comprendere la fase politica attuale.
Ernesto Laclau, La ragione populista, Laterza, Roma-Bari, 2008.
Citazioni

“Ho mostrato come l’equivalenza e la differenza siano di per sé incompatibili; nondimeno, esse si esigono a vicenda come condizioni necessarie per la costruzione del sociale. Il sociale non è nulla se non il luogo di questa tensione irriducibile. E il populismo? Se non è possibile una separazione netta tra le due logiche, perché possiamo dire che il populismo tende a privilegiare il momento equivalenziale? E soprattutto che cosa significa «privilegiare» in questo contesto? Esaminiamo con cura la questione. Ciò che ho detto circa la totalizzazione, l’egemonia e i significanti vuoti ci fornisce gli indizi utili a risolvere l’enigma. Da un lato, ogni identità sociale (cioè discorsiva) si costituisce ne] punto di incontro tra differenza ed equivalenza — così come le identità linguistiche sono la sede sia di relazioni sintagmatiche (combinazione) sia di relazioni paradigmatiche (sostituzione). Dall’altro, però, il sociale non è mai uniforme né regolare, poiché, come visto, la totalizzazione esige che un elemento differenziale giunga a rappresentare un intero impossibile. (I simboli di Solidarnosc, per esempio, non rimasero le domande particolari di un gruppo di lavoratori a Danzica, ma finirono per significare un campo popolare ben più ampio, schierato contro un regime oppressivo.) Così, una certa identità è prescelta dall’intero campo delle differenze, per incarnare questa funzione totalizzante. Ecco allora — per rispondere alla domanda precedente — che cosa significa «privilegiare». Ripristinando una vecchia categoria fenomenologica, potremmo dire che questa funzione consiste nel porre l’orizzonte del sociale, il limite di ciò che è rappresentabile al suo interno (abbiamo già parlato del rapporto tra il limite e la totalità).
La differenza tra una totalizzazione istituzionalista e una totalizzazione populista va cercata al livello di quei significanti privilegiati, egemonici che strutturano, come punti nodali, l’insieme di una formazione discorsiva. Differenza ed equivalenza sono presenti in entrambi i casi, ma un discorso istituzionalista si sforza di far coincidere i limiti della formazione discorsiva coi limiti della comunità: il principio universale della «differenzialità» diventa l’equivalenza dominante all’interno di uno spazio comunitario omogeneo. (Si pensi ad esempio all’«una nazione» di Benjamin Disraeli.) Mentre accade l’opposto col populismo: una frontiera di esclusione divide la società in due campi, II «popolo», in questo caso, è qualcosa di meno della totalità dei membri di una comunità: è una componente parziale, che ciononostante aspira a essere considerata l’unica totalità legittima. La terminologia tradizionale — che è passata nel linguaggio comune — precisa questa differenza: il popolo può essere concepito come populus, il corpo di tutti i cittadini, oppure come plebs, i sottoprivilegiati. Perfino questa distinzione, però, non afferra esattamente il punto. Essa, infatti, può facilmente apparire come una distinzione giuridica, e in tal caso si ridurrebbe a una distinzione fatta all’interno di uno spazio omogeneo, che dà legittimazione universale a tutte le sue parti componenti — ciò significa che la relazione tra i suoi due termini non sarebbe mai antagonistica.
Per ottenere il «popolo» del populismo, abbiamo bisogno di qualcosa di più: abbiamo bisogno di una plebs che reclami di essere l’unico populus legittimo — abbiamo bisogno di una parzialità che pretenda di fungere da totalità della comunità. («Tutti i poteri ai Soviet», o enunciati equivalenti in altre formazioni discorsive, è un esempio perfetto di rivendicazione populista.) Nel caso di un discorso istituzionalista, abbiamo visto che il principio di differenzialità reclama di essere l’unico equivalente legittimo: tutte le differenze sono considerate egualmente valide all’interno di una totalità più ampia. Nel caso del populismo, invece, questa simmetria è rotta: c’è una parte che si identifica col tutto. Ed ecco allora, come già abbiamo segnalato, che una radicale esclusione ha luogo all’interno dello spazio comunitario. Nel primo caso, il principio di differenzialità è l’unica equivalenza dominante; nel secondo caso, ciò non basta: il rifiuto di un potere, realmente attivo all’interno di una comunità, richiede l’identificazione di tutti gli anelli della catena popolare con un principio identitario che cristallizzi tutte le differenti domande attorno a un denominatore comune, che esige ovviamente un’espressione simbolica positiva. Questo è il passaggio da quelle che abbiamo definito domande democratiche alle domande popolari. Le prime si possono soddisfare con l’espansione di una formazione egemonica. Le seconde rappresentano una sfida secca alla formazione egemonica (pp. 76-77).
“Di un’ultima, cruciale dimensione va tenuto ancora conto nella nostra analisi. Il nostro approccio al populismo ruota attorno alle seguenti tesi: (l) l’emergenza del «popolo» richiede il passaggio, via equivalenze, da domande isolate, eterogenee a una domanda «globale», che implica la formazione di frontiere politiche e la costruzione discorsiva del potere come una forza antagonistica; (2) dato però che questo passaggio non può essere dedotto da una mera analisi delle domande eterogenee, non c’è alcuna transizione logica, dialettica o semiotica da un livello all’altro — deve intervenire qualcosa di qualitativamente nuovo. Ed ecco perché la nominazione può avere gli effetti retroattivi che ho descritto.
Questo momento qualitativamente differenziato e irriducibile è quanto ho battezzato «investimento radicale». Non mi sono ancora soffermato abbastanza, tuttavia, su questa nozione di «investimento». Le diverse operazioni di significazione a cui ho fatto riferimento fin qui possono spiegare le forme che l’investimento assume, ma non la forza in cui l’investimento consiste. È chiaro, nondimeno, che se una qualche entità diventa l’oggetto di un investimento — come accade nell’amore o nell’odio l’investimento appartiene necessariamente all’ordine degli affetti” (p. 104).
“L’intero sarà sempre incarnato da una parte: non c’è universalità che non sia egemonica. Ma c’è anche di più: come negli esempi dei primi piani e del «valore-seno» del latte discusso da Copjec, non c’è nulla nella materialità delle diverse parti che predestini l’una o l’altra a fungere da totalità. Nondimeno, una volta che una certa parte abbia assunto simile funzione, è la sua materialità stessa di parte a diventare fonte di godimento. Gramsci formulò la questione politica in termini simili: quale forza sociale diventi la rappresentazione egemonica della società come un tutto è deciso ogni volta da una lotta contingente; ma una volta che una particolare forza sociale sia divenuta egemonica, essa rimarrà tale per un intero periodo storico. L’oggetto dell’investimento può essere contingente, ma certo non è indifferente — insomma, non può essere cambiato a piacere. Con ciò, abbiamo raggiunto una spiegazione esauriente di ciò che significa «investimento radicale»: rendere un oggetto l’incarnazione di una pienezza mitica. L’affetto (vale a dire il godimento) è l’essenza stessa dell’investimento, mentre il suo carattere contingente rende conto della componente «radicale» della formula.
Voglio spiegarmi bene su questo. Non abbiamo qui a che fare con omologie casuali o esteriori, ma con la stessa scoperta, fatta in due ambiti diversi — psicoanalisi e politica —, di qualcosa che riguarda la struttura stessa dell’oggettività. La principale conseguenza ontologica della scoperta freudiana dell’inconscio è che la categoria di rappresentazione non riproduce, a un livello secondario, una pienezza anteriore, che si potrebbe afferrare pure in modo diretto; piuttosto, la rappresentazione si impone come il livello assolutamente primario di costituzione dell’obiettività. Ecco perché non esiste significazione che non sia sovradeterminata sin dall’inizio. Essendo la pienezza della madre primordiale un oggetto puramente mitico, non è possibile agguantare la jouissance se non attraverso l’investimento radicale in un objet petit a. In tal modo, l’objet petit a diventa la categoria ontologica primaria. Ma la stessa scoperta (non semplicemente una scoperta analoga) è stata fatta dalla teoria politica. Nessuna pienezza sociale è raggiungibile se non attraverso l’egemonia. E l’egemonia non è altro che l’investimento, in un oggetto parziale, di una pienezza sempre sfuggente perché puramente mitica (è il rovescio positivo di una situazione sperimentata come «essere manchevole»).
La logica dell’objet petit a e la logica egemonica non sono soltanto simili: sono identiche. Ecco perché, nella tradizione marxista, Gramsci rappresenta un momento di cruciale rottura epistemologica: mentre il marxismo tradizionale ha sempre nutrito il sogno di accedere a una totalità sistematicamente chiusa (determinata in ultima istanza dall’economia, ecc.), l’approccio egemonico rompe in maniera decisa con questa logica sociale essenzialista. L’unico possibile orizzonte totalizzante è dato qui da una parzialità (la forza egemonica) che diventa la rappresentazione di una totalità mitica. in termini lacaniani: un oggetto è elevato alla dignità della Cosa. L’oggetto dell’investimento egemonico non è, allora, un ripiego rispetto alla Cosa, che sarebbe di per sé una società interamente pacificata (una totalità sistematica che non richiederebbe più alcun investimento né alcuna egemonia): è semmai il nome che la pienezza riceve all’interno di un certo orizzonte storico, un nome che in quanto oggetto parziale di un investimento egemonico non è un semplice surrogato, ma il punto di raccordo di attaccamenti appassionati” (pp. 109-110).
“La nostra esplorazione giunge così al termine. L’emergenza del «popolo» dipende dalle tre variabili che ho messo in rilievo: rapporti equivalenziali rappresentati egemonicamente da significanti vuoti; spostamenti delle frontiere interne tramite la produzione di significanti fluttuanti; e un’eterogeneità costitutiva che rende impossibile qualsiasi ricucitura dialettica, conferendo un’autentica centralità all’articolazione politica. Abbiamo raggiunto in tal modo una nozione più elaborata di populismo” (pp. 147-148).
Tags: popolo populismo razzismo