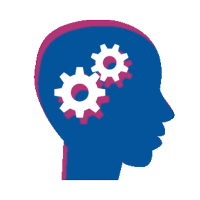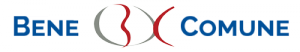“L’eredità di quanto si manifestò nel ’68 non è nelle risposte e nelle proposte che allora furono elaborate. E’ davvero nella ripresa di quel grido, profetico al di là di quel che allora si percepiva: questo non è che l’inizio”. Questa frase sulla copertina ben riassumono la tesi di questo piccolo, intrigante e interessante volumetto, quasi un pamphlet moderato, sull’eredità del ’68.
L’autore, Paolo Pombeni, si definisce uno che ha vissuto il ‘68 dalla quinta fila, quando aveva 20 anni. Dopo una carriera universitaria come professore di Storia dei sistemi politici europei e di Storia dell’ordine internazionale presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, prova a fare un bilancio dell’esperienza del ’68 a cinquant’anni di distanza, tempo che permette a uno storico di avanzare qualche riflessione e interpretazione sufficientemente posata.
Gli otto capitoli prendono in esame vari aspetti di quel fenomeno e ne cercano le influenze nel tempo successivo. Essi riguardano la questione scolastica, il contesto “rivoluzionario” internazionale, il passaggio dal capitalismo al consumismo, il Concilio Vaticano II e il suo influsso, la questione femminile, la questione politica di un riformismo abortito, la fine dell’autorità, la globalizzazione. Una breve conclusione di bilancio e una proposta: «Le giovani generazioni potrebbero avere un compito e un’occasione di importanza storica: riuscire a stabilizzare in senso positivo, a dare uno sbocco costruttivo alla grande transizione in cui ci troviamo coinvolti, si potrebbe dire immersi. Quella svolta, rivoluzione, transizione (la chiami come si vuole), che i giovani sessantottini intuirono in termini vaghi, più per sensibilità che per ragione, e che oggi è diventata palese, vorrei dire quasi palpabile. Se e quando riuscissero in questa impresa, le nuove generazioni potrebbero guardare con indulgenza e forse con qualche considerazione a quanto è accaduto dal Sessantotto ad oggi, riconoscendo che effettivamente quello non era che l’inizio» (p. 128).
La disanima storica dei vari aspetti del ’68 chiarisce le questioni in gioco allora e le conseguenze nel tempo. Ci sono alcuni giudizi che riaffiorano qua e là («Basta vedere gli argomenti dei temi (di maturità, ndr) […] per capire che si educano persone che alla fine cadranno vittime di tutte le leggende metropolitane che il nuovo sistema di comunicazione, quello della mitica “rete”, fa circolare senza problemi. Del tutto in disuso sembrano essere caduti i percorsi destinati alla formazione della coscienza civica», p. 24) e che l’autore sintetizza così: «Questo è il problema di una eredità in cui sopravvivono più gli elementi utopici nell’immaginare il nostro futuro, che le componenti razionali utili a circoscrivere i problemi, per provare a risolverli, di un mondo divenuto sempre più interconnesso» (p. 116).
Il Sessantotto non è stato il semplice precipitato di una fase storica precedente, ma anche le conseguenze non sono dovute tutte e solo a quel periodo. La attuale rivoluzione tecnologica-digitale, per esempio, non era minimamente all’attenzione dei giovani studenti di allora e neanche dei lavoratori, ma neanche prevedibile nelle forme che abbiamo conosciuto. Solo da 10 anni abbiamo gli smartphone, con le loro app, per esempio.
Pombeni lamenta che la pars destruens è stata grande e ricca, mentre la pars construens non ha ancora prodotto una sintesi pacificata e condivisa culturalmente, non c’è un idem sentire de re publica. Anzi il conflitto tra le varie classi, o parti di popolo, o segmenti della società (preferite voi la denominazione), è forte e non accenna a diminuire, al contrario di quanto accadde dopo la seconda guerra mondiale, almeno in occidente e fino al ’68.
La modernità, «come specifico modo di intendere il rapporto dell’uomo con il mondo» in termini nuovi rispetto a quanto elaborato nel Medioevo e nell’antichità classica, si è sviluppato a partire dalla metà del ‘400, essendo «il suo punto focale e il perno dei suoi sviluppi evoluti nel riconoscimento della razionalità come centro e motore del rapporto dell’uomo con l’universo, ma anche con la storia, non solo passata, quanto presente e persino futura» (p. 123).
Il ’68, con i suoi slogan: «l’immaginazione al potere», «siate realisti, chiedete l’impossibile», la critica della razionalità borghese, mostrava le prime crepe della dimensione razionale come unica guida della vita dell’umanità.
Le questioni che le inquietudini del ’68 ha manifestato sono ancora tutte sul tappeto della storia, afferma Pombeni. Il Sessantotto ha iniziato ad affrontarle, ma non le ha risolte, avviando delle soluzioni solo iniziali. Da qui l’appello finale, ripreso all’inizio di questa recensione, ai giovani affinché prendano con intelligenza il testimone e continuino a correre come in una staffetta per passare il testimone alle generazioni future.
Paolo Pombeni, Che cosa resta del ’68, Il Mulino, Bologna 2018.
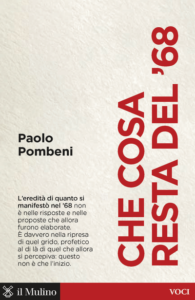 Citazioni
Citazioni
“Il Sessantotto fu molte cose, ma fu senz’altro in gran parte un’operazione intellettuale” (p. 10).
“Ciò che non ci si aspettava era che ‘urto della contestazione giovanile avrebbe sfondato con facilità, perché davvero, per parafrasare un riferimento che andava di moda all’epoca, i sostenitori del vecchio sistema si rivelarono tigri di carta” (pp. 11-12).
“Ma era più un gioco di specchi che non un farsi carico delle complessità dei grandi problemi, in nome dei quali si abbandonava a un triste destino il faticoso e impegnativo riformismo di cui aveva bisogno l’Italia” (p. 13).
“Non era affatto, come dissero molti avversari, una rivolta nichilista, perché davvero si credeva fosse possibile costruire una nuova civiltà sugli spazi conquistati” (p. 16).
“Ci fu allora un impegno alla riflessione che, pur con tante ingenuità, non fu più rinnovato. La fuga nell’utopia sarà il cascame del fallimento dei sogni di allora, nell’illusione che ciò che non si era potuto costruire con la ragione alternativa si sarebbe potuto fare col miracolo del ritorno allo stato di natura” (p. 17).
“Dunque quella che abbiamo chiamato la seconda rivoluzione degli intellettuali (la prima era quella del 1848, ndr) ha alla fine prodotto il tramonto della razionalità occidentale? […] Si può solo dire che cinquant’anni dopo è venuto il momento di provare ad offrire un quadro di ciò che resta del Sessantotto. Non sarà un quadro trionfalistico, né sconsolato. La storia non procede per sorti magnifiche e progressive. Si viene facendo in mezzo a quel groviglio di debolezze e di speranze, di progettualità e di verifiche amare che sono gli uomini nel loro vivere concreto” (p. 18).
“La prima eredità ambigua con cui ci si dovrebbe misurare è il conflitto permanente che si è instaurato fra il soggettivismo e l’autorità, combattuta come autoritarismo” (p. 23).
“In conclusione va fatta un’ultima amara notazione. Uno degli obiettivi della contestazione sessantottina era eliminare o almeno fortemente ridurre le discriminazioni di classe presenti nel sistema educativo. Oggi sembra invece che esse siano notevolmente incrementate” (p. 29).
“Se c’è un mito che ha distinto il Sessantotto da altre fasi di protesta scaturite da movimenti intellettuali, questo è stato l’operaismo” (p. 31).
“L’esito più drammatico di questa vicenda è stata la chiusura dei sindacati verso le esigenze delle giovani generazioni” (p. 37).
“In definitiva ciò che resta di una lunga stagione di lotte per il lavoro è una svalutazione pesante del valore del lavoro stesso” (p. 40).
“Tutto questo a scapito di quella fede in un mondo fondato sulla classe lavoratrice, avanguardia della marcia verso il progresso, che aveva animato tanta parte del Sessantotto. Erano parole sulla carta che avevano trovato, anche più di altre, grandi difficoltà a diventare cultura a favore del bene comune” (p. 42).
“Si potrebbe banalmente ricordare che in realtà, più che investire in deficit, lo Stato distribuì in deficit redditi che non erano stati prodotti (l’esplosione del sistema pensionistico ed assistenziale) e sostenne spese che non producevano ritorno” (p. 48).
“La forbice delle disuguaglianze sociali si è molto allargata […] i consumi non sono più un traino reale per la creazione di nuova produttività, e di conseguenza di nuova ricchezza […] Il capitalismo è divenuto prevalentemente finanziario e ciò lo allontana dalle dinamiche sociali legate al territorio” (p. 51).
“Sta di fatto che la grande critica al capitalismo non solo non ne ha fermato lo sviluppo, ma non ha neppure più l’appeal di un tempo […] A pagare le spese di questa crisi del capitalismo sono soprattutto i giovani afflitti da una disoccupazione che si pensava sconfitta definitivamente […] Eppure questi giovani non sembrano, almeno per il momento, pensare alla rivoluzione, a meno che non si rivelino la grande riserva per un successo politico dei movimenti populisti al cui affermarsi stiamo assistendo attoniti e sconcertati” (p. 52).
“A cinquant’anni di distanza dal mitico spartiacque del 1968, la Chiesa italiana (o, se si preferisce, «le Chiese», perché il paese era variegato) si presenta radicalmente mutata […] il modo di essere della religione cattolica e la sua presenza nella società italiana sono quanto mai distanti da quella restaurazione che una Chiesa uscita dal terremoto della Seconda guerra mondiale si era illusa di poter dirigere e governare” (p. 65).
“Col tempo, si finì comunque per scoprire che, come suol dirsi, non era tutto ora quel che luccicava. Per liberato che fosse, il ruolo della donna aveva delle peculiarità che non erano così facilmente ignorabili. Equilibrare il ruolo di lavoratrice con quello di madre non era così semplice” (p. 75).
“La generazione del Sessantotto – specie quella degli universitari – si trovò, per la prima volta dal dopoguerra, a confrontarsi con un mondo dei partiti che non aveva più attrattive” (p. 80).
“L’enfasi pseudo rivoluzionaria che era durata più o meno un decennio lasciò in eredità un approccio radicaleggiante nella lettura della nostra storia e della nostra politica” (p. 86).
“L’Italia continuava ad essere vista come «un paese sbagliato», che non era riuscito a realizzare una modernizzazione appropriata, che era nelle mani di ceti dirigenti corrotti e incapaci, e che doveva sperare nell’arrivo di un qualche messia, individuale o collettivo, che fosse capace di rimetterlo sui binari. Molte narrazioni cambiavano magari di segno, ma restavano ancorate al pregiudizio della mancata rivoluzione postfascista” (pp. 86-87).
“Finché ressero le agenzie di aggregazione ideologica (fossero i partiti politici o le comunità religiose), la competizione fra loro lasciava qualche margine anche nell’affermarsi dei meriti e delle creatività. Quando tali agenzie entrarono in crisi e per difendersi divennero sempre più campi fortificati dove vigeva una stretta autoreferenzialità, le cattive pratiche del preferire comunque da parte di ciascuno «i propri» si estesero e divenne sempre più difficile sottoporle a critiche e controlli […] In tale contesto, in ultimo, a finire delegittimato fu l’universo riformatore” (pp. 88-89).
“Il paese venne così privato di una cultura riformista e riformatrice, giudicata una specie di oppio per intellettuali e politici un poco ottusi, per mettere sugli altari al suo posto la combinazione di una critica anarchica verso l’esistente e dell’attesa millenaristica di una uova età dell’oro, che da destra e da sinistra si predicava essere disponibile dietro l’angolo solo che ci si fosse affidati a chi aveva le ricette giuste e si fossero accolti senza tentennamenti i suoi anatemi contro l’esistente” (p. 90).
“Che fosse settario o più aperto ai valori dell’occasionalità delle convergenze, il comunitarismo lasciò un’impronta profonda nella psicologia sociale per lunghi decenni” (p. 97).
“Lo spirito di solidarietà reciproca fra gli appartenenti a un certo gruppo è un valore che va preservato, perché senza di esso i gruppi non crescono e non migliorano le loro perfomarce. Il principio per cui le doti di cui ogni individuo dispone sono in fondo un dono che ha ricevuto perché contribuisca alla crescita del bene comune fa parte della componente nobile della «politica», cioè di ciò che tiene insieme una comunità che condivide lo stesso destino per lo sviluppo della polis” (pp. 101-102).
“Una delle eredità più stabili del Sessantotto fu l’introduzione di un’attenzione diffusa al contesto internazionale” (p. 105).
Tags: Sessantotto