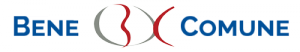Aldilà dell’evidente fatuità di un gioco snobistico per dame e gentiluomini dell’aristocrazia che si davano nomi mitologici con cui firmavano mediocri componimenti poetici, c’è qualcosa di incredibilmente importante da recuperare dal mito dell’Arcadia. E lo fa quello che a mio parere è stato forse l’ultimo vero Padre della Chiesa, Gilbert Keith Chesterton, che in un suo articolo intitolato ‘In difesa delle pastorelle di ceramica’ scriveva: ‘Il concetto di pastore ideale è assurdo per la nostra mentalità moderna e senza dubbio la realtà economica che ci circonda è ben diversa da quello scenario di pace rappresentato nella poesia pastorale, che a noi appare artificioso e ingenuo. Eppure quello di Pastore Ideale è stato il solo mestiere del popolo a conquistare un posto accanto alle occupazioni dell’aristocrazia, pari a loro per nobiltà e importanza’.
Avere un ideale verso cui tendere non è prerogativa dei mestieri ‘di moda’ o ‘considerati prestigiosi o culturalmente sofisticati’, nulla vieta di tracciare un profilo di ‘Impiegato delle poste ideale’. Anzi, sicuramente, un impiegato delle poste che si metta a disposizione con sorridente amabilità di poveri utenti sfiniti da file e complicazioni burocratiche avrebbe una dignità altissima per la quantità di bene prodotta. Io sicuramente lo stimerei immensamente di più del professore universitario da talk-show che mostra il suo disprezzo per il prossimo sfornando analisi con sorrisetto a boccuccia di gallina (ieri ne ho visto uno che sembrava finto per quanto era paradigmatico). Il nostro popolo ha sempre intuito la nobiltà insita nei mestieri umili (a Roma le persone anziane chiamano ancora ‘Maestro’ un artigiano abile e onesto).
Avere un ideale verso cui tendere è quello che salva una società dal degrado, avere un ideale verso cui tendere da cercare nell’infinita dignità di ogni lavoro è ciò che la modernità ha avversato con tutte le sue forze (solo l’educazione formale scolastica eleva l’uomo dal suo stato ferino), è ciò che socialismo e comunismo hanno considerato anatema (il mondo è diviso in padroni e servi), è ciò che l’odierna post-modernità irride (farcela significa essere belli e vincenti). Solo la Chiesa Cattolica (l’unico luogo dove, almeno fino ad ora, colti e semplici avevano la stessa dignità e spiritualmente uno spazzino poteva dare dei punti a un professore) con i santi patroni dei diversi mestieri ha plasticamente rappresentato l’ideale del lavoro. Insomma nostro Signore faceva il falegname, non il manager o il professore ad Harvard.
Tutto questo sproloquio sull’Arcadia mi deriva dalla profonda amarezza che mi è sorta stamattina analizzando i dati di un grande studio americano sull’effetto degli antidepressivi. Si tratta di uno studio enorme che riporta i dati di più di quattromila pazienti affetti da ‘Depressione Maggiore’ (MD), una malattia mentale che colpisce il 10% della popolazione mondiale e che si stima nel 2030 sarà la prima causa di invalidità nel mondo sviluppato (ora è la terza). I dati dello studio riportano, insieme alle valutazioni cliniche dell’effetto dei farmaci, una serie di dati demografici e di condizioni di vita dei pazienti, questi dati sono pubblici e quindi con i miei colleghi qui all’Istituto li stiamo analizzando per avere delle informazioni sui motivi dello scarso successo degli approcci farmacologici. La cosa inquietante è che gli indicatori prognostici più efficaci della probabilità di guarigione (o almeno di miglioramento) sono tutti legati alla situazione sociale dei pazienti. Detto in breve: i ricchi guariscono di più dei poveri.
Nell’Ottocento, i viaggiatori Italiani in Inghilterra erano unanimi nel commentare come, mentre dalle parti nostre non ci fosse alcun legame tra condizione sociale e felicità (i poveri erano anzi spesso più contenti dei ricchi), in Inghilterra il popolo vivesse in condizioni raccapriccianti di degrado morale e amarezza.
La modernità aveva fatto il suo lavoro nell’isola, lavoro che in Italia, è stato fortunatamente ostacolato dalle nostre peculiarità religiose e culturali, ora i dati del mega-trial sulla depressione mi mettono inquietudine. Vorrei immaginare che questa ennesima piaga non ci raggiunga, vorrei trovare assenza di correlazione tra posizione sociale e depressione nella mia patria, non ho dati e quindi non posso fare i calcoli.
Però sogno che sia ancora così, intanto credo che avremmo bisogno di qualche scalcinato Arcade che metta in risalto l’intrinseca nobiltà degli addetti alle pulizie, dei guidatori di autobus, di portinaie e banchisti del mercato rionale. Dovrebbe essere anche compito del clero, ma lì vedo un po’ troppi borghesi ‘moderni’…speriamo bene.