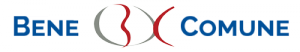ed in particolare, sulla scorta anche delle affermazioni di Benedetto XVI, ci si è concentrati sul profilo etico e antropologico di questa crisi, notando come essa coinvolga la categoria della fiducia e in generale il piano relazionale. In questo senso, non posso che aderire alle riflessioni fatte – tra gli altri – da F. D’Agostino sull’Avvenire, e da G. Grandi su Benecomune.
Ma una domanda, agli economisti e ai teorici, la voglio pur fare, nella particolare prospettiva in cui, per formazione, mi colloco; ovvero, non da tecnico, non da economista, ma da filosofo, e da cristiano.
La domanda, nuda e cruda, è questa: non sarà che ci stiamo affannando a trovare giustificazioni etiche per costringere al bene qualcosa che, al fondo, non lo sarà mai? O ancora più chiaramente: nel migliore dei mondi possibili, laddove cioè la finanza si fondasse sulla fiducia reciproca e generasse relazioni di serio affidamento, potremmo essere davvero certi di trovarci di fronte a una dimensione autentica di Bene?
Cerco di spiegarmi, argomentando le mie perplessità, sapendo anche di non avere una risposta in tasca (e per questo rivolgo la domanda).
In tutte le tre grandi religioni monoteiste è espresso, in modo chiaro e netto, il divieto di usura; ed è espresso in termini semplici: “non farai al tuo fratello prestiti ad interesse, né di denaro né di viveri, né di qualunque cosa che si presta ad interesse” (Deuteronomio, 23,20). Analoghe affermazioni sono presenti in moltissimi altri passi della Bibbia, così come nel Corano. Perché?
Da profano (ancora una volta), credo che una sapienza antica sottenda questi divieti, una sapienza umana e sociale; le relazioni economiche sono buone perché, producendo ricchezza, migliorano la nostra vita su questa terra, e ciò è possibile nella misura in cui incrementano i beni di cui l’uomo, e la comunità tutta, possono disporre. In altri termini, abitare la terra significa metterla a frutto, produrre quei beni che, ben utilizzati, contribuiscono a costruire il Bene. Il bene comune, il bene dell’uomo, e così via.
L’usura, per contro, è fuori da questa dinamica antropologicamente e socialmente positiva, perché produce solo ricchezza, ma non produce bene. Più esattamente, producendo denaro tramite denaro, incrementa solo la ricchezza, ma non i beni di cui la comunità dispone, e dunque non costruisce il bene comune. Se l’uomo si affanna a produrre, a costruire, a inventare, a scambiare e far circolare i beni, questo rende davvero santa la relazionalità economica, perché è la base per l’edificazione della città dell’uomo, di una comunità che cerca di accrescersi e vivere al meglio, amministrando in modo onesto e scaltro i beni che il Signore le ha affidato. Ma se l’uomo si limita a moltiplicare la ricchezza con se stessa, senza che questo si traduca nei beni concreti dei quali si sostanzia la vita della comunità, allora non c’è più nulla di santo, nulla di buono.
Tornando a noi, e alla nostra crisi, allora, credo che si debba ragionare seriamente, da cristiani, sulla metamorfosi della nostra economia, e sulla sua trasformazione (inevitabile?) da economia di produzione (che pure in parte continua, per fortuna, ad essere), ad economia finanziaria. Ne parlo da incompetente, ma non sarà che l’aver messo al centro del sistema economico le banche, i fondi, le banche d’affari, i broker, sia in sé un male? Non sarà che, per quante regole ci possiamo inventare, per quanto si possa sperare di ricostruire la fiducia dei mercati, per quanto gli Stati possano impedire gli abusi, aver spostato l’asse dell’economia occidentale dalla produzione di beni alla matematica finanziaria sia in sé qualcosa di (eticamente) sbagliato?
Per concludere col riferimento alla fiducia: mi potrò mai fidare davvero di un usuraio?