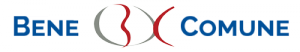Il decreto-legge n. 113 del 2018 – noto come “decreto Salvini” e convertito dal Parlamento con la legge n. 132 del 2018, sotto la generica insegna della sicurezza – ha disciplinato tematiche tra loro differenti e, dunque, non omogenee: la riscrittura della normativa in materia di permessi di soggiorno e di protezione internazionale e immigrazione; alcune misure per la sicurezza pubblica, la prevenzione e il contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa; interventi per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Con il consueto e discutibile approccio emergenziale – perseguito più per limitare il confronto parlamentare che per risolvere una reale emergenza – il governo ha inteso confezionare un primo intervento legislativo per affrontare il fenomeno migratorio e per rafforzare gli strumenti a garanzia della sicurezza pubblica, mescolando e confondendo l’uno e gli altri, e mettendo in tal modo al centro della propria azione e del dibattito pubblico il tema della sicurezza.
In continuità con il decreto-legge n. 14 del 2017 sono state rafforzate alcune misure per la “sicurezza urbana”, quali la possibilità per il personale delle polizie locali di sperimentare armi ad impulsi elettrici, note come “taser”, la facoltà per i regolamenti comunali di estendere l’obbligo di allontanamento alle aree urbane su cui insistono presidi sanitari, o alle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, la previsione dell’arresto nel caso di violazione del divieto di accesso, il cosiddetto “DASPO urbano”, il potere del questore di imporre il divieto di accesso anche per i pubblici esercizi o i locali di pubblico intrattenimento ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, nonché la possibilità per i gestori di pubblici esercizi di collaborare con le forze di polizia per la prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Finalizzati alla tutela della “sicurezza urbana” sono inoltre l’estensione del potere di ordinanza del sindaco alle aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, il possibile reclutamento di nuovo personale di polizia locale e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
Un discutibile intento securitario muove l’introduzione del delitto di accattonaggio molesto, nonché l’inasprimento delle sanzioni per quanti esercitano abusivamente l’attività di parcheggiatore o si rendono responsabili di un blocco stradale o dell’invasione o occupazione di terreni o edifici. Nel medesimo solco si colloca anche la rivisitazione della disciplina dell’occupazione arbitraria di immobili, che prevede tra l’altro il potere del prefetto di predisporre un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, nonché la possibilità di differire lo sgombero degli immobili a fronte della corresponsione di una indennità per i proprietari.
Anche il nuovo governo asseconda la tendenza a rileggere il governo delle città attraverso la lente della sicurezza, a trasformare i bisogni, soprattutto sociali, delle comunità locali in questioni di (in)sicurezza, molte volte a scapito del pluralismo, delle differenze, delle libertà. Continuiamo ad assistere ad una torsione securitaria di interventi che dovrebbero avere un carattere prevalentemente sociale, ad una semplice “rimozione” dei conflitti sociali, del disagio, delle fragilità. Se da un lato si alimenta la “criminalizzazione” di chi versa in situazioni di disagio o di chi assume comportamenti “antisociali”, dall’altro lato manca la prospettazione di misure “positive” per rimuoverne e superarne le cause, per eliminare o almeno ridurre i fattori “criminogeni” o di “devianza”.
Ulteriori scelte operate dal medesimo legislatore hanno destato perplessità e censure. È il caso della riforma delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, per le quali si prevede la vendita ai privati dei beni di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse. Evidente è il rischio denunciato dalle associazioni e dai sindacati che gli stessi beni ritornino nella disponibilità delle organizzazioni criminali e che la vendita rappresenti un arretramento dei poteri pubblici a fronte delle difficoltà del loro pieno ed effettivo riutilizzo sociale. La vendita dovrebbe rappresentare una misura estrema e residuale presidiata da opportuni e più stringenti controlli.
Ma è la riscrittura della normativa in materia di immigrazione che alimenta le maggiori criticità. Muovendo dalla convinzione che l’immigrazione costituisce un fattore criminogeno e accresce la (percezione di) insicurezza, il decreto-legge introduce una normativa volutamente restrittiva delle condizioni di accesso e permanenza sul nostro territorio dei migranti.
In primo luogo interviene sulla disciplina della cittadinanza subordinando la concessione della cittadinanza italiana alla prova del possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). È innalzato a 250 euro l’importo del contributo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia e concessione della cittadinanza ed è esteso a 48 mesi (rispetto ai 24 precedenti) il termine per la conclusione del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio e per residenza. È altresì prevista la revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 10 anni.
In secondo luogo l’atto governativo ripensa gli strumenti per l’accoglienza dei migranti “smantellando” il sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati (SPRAR), gestito dai comuni, che fino ad oggi ha garantito un’accoglienza ed un’integrazione diffusa sul territorio. Il decreto riconosce agli enti locali la possibilità di prestare servizi di accoglienza ai soli titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. Non potranno invece essere accolti nelle strutture locali i nuovi richiedenti asilo, che dovranno attendere presso i centri di accoglienza l’esito delle procedure amministrative. In tal modo i nuovi richiedenti saranno esclusi dai percorsi di integrazione fino ad oggi garantiti dallo SPRAR, mentre i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria tuttora ospitati nell’ambito del sistema di protezione vi potranno restare sino alla scadenza del progetto di accoglienza, dopo, se l’istanza di asilo non è accolta o non rientrano nelle nuove ipotesi di protezione “speciale”, saranno considerati “irregolari” e avviati sulla strada della “clandestinità”.
Escludere i richiedenti dal sistema di protezione vuol dire negare loro l’esperienza di integrazione con la comunità locale, di sperimentare e vivere un percorso di accoglienza ed inclusione.
Inoltre il richiedente asilo per la determinazione o la verifica dell’identità o della cittadinanza potrà essere trattenuto, per un tempo comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le aree c.d. hotspot (punti di crisi) allestite nei luoghi dello sbarco. Contestualmente è prolungato a 180 giorni il tempo massimo di trattenimento dei migranti nei Centri di permanenza per il rimpatrio.
In terzo luogo il decreto-legge incide profondamente sulla disciplina nazionale della protezione per motivi umanitari sopprimendola come istituto generale e mantenendo singole tipologie di protezione “speciale”. Il permesso di soggiorno umanitario introdotto nel 1998 – della durata di due anni -, insieme all’asilo politico e alla protezione umanitaria, ha rappresentato una delle forme di protezione che poteva essere riconosciuta ai richiedenti asilo. I nuovi permessi, della durata massima di un anno, non solo mirano a rendere del tutto eccezionali e circoscritte le ipotesi di protezione umanitaria, ma rendono più precaria la condizione giuridica ed umana del titolare.
L’intervento governativo, infine, intende “compromettere” ulteriormente la condizione dei richiedenti asilo. Volutamente il governo ha eliminato la possibilità per i richiedenti asilo di poter frequentare i corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell’ente locale dedicato all’accoglienza del richiedente. Inoltre, il decreto-legge sancisce che il permesso di soggiorno rilasciato ai richiedenti asilo (valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale) non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica presso i comuni.
Il richiedente asilo, escluso dal sistema di protezione, potrà soggiornare solo presso le strutture di prima accoglienza e in quelle temporanee, strutture che costituiranno il suo domicilio. Si tratta di una disposizione che ha generato l’opposizione, anche letta come “disobbedienza civile”, di molti sindaci italiani, che, negando ai richiedenti asilo il “diritto alla residenza”, ne denunciano l’incostituzionalità e che sono preoccupati di doverli escludere dalla erogazione dei servizi che presuppongono l’iscrizione anagrafica. A fronte della possibilità per gli amministratori locali e per le singole persone di far valere giudizialmente i concreti sospetti di incostituzionalità e di contrastare la volontà discriminatoria sottesa non solo a questa disposizione, ma anche a numerose norme del decreto, rimane la possibilità per il richiedente tanto di provare in maniera differente l’abituale dimora ai fini dell’iscrizione all’anagrafe, quanto di accedere ai servizi ad esso riconosciuti.
È solo da una lettura complessiva del decreto che si disvela l’orizzonte culturale e politico prefigurato dal governo: la volontà di legare immigrazione e (in)sicurezza per rafforzare la convinzione che i migranti mettono a rischio la sicurezza della comunità. Una scelta dettata dal calcolo politico e dall’emotività, che finisce per alimentare un circolo vizioso tra percezione e decisione pubblica. La decisione pubblica insegue la percezione di insicurezza e al contempo genera percezione di insicurezza, una escalation di cui non si vede la fine.
La sicurezza è invocata e brandita per governare le nostre città. Il governo della res publica si risolve nell’amministrazione della sicurezza. Bisogna allora domandarsi: che città vogliamo? Che comunità vogliamo?
Un’altra strada è possibile tracciare e percorrere. Una comunità più integrata attua a suo modo una rete di protezione e controllo che affianca l’attività di prevenzione e di repressione dei reati e al contempo contribuisce ad impedire il radicamento di fenomeni criminali. Non possiamo tacere il rischio di una torsione securitaria delle politiche sociali, ovvero il rischio di risolvere i problemi (e i conflitti) sociali che attraversano le nostre città con interventi che hanno come finalità la sicurezza.
Nel dibattito pubblico l’attenzione è volutamente spostata sui rischi, sui pericoli, sulle incertezze, sulle paure, sulla criminalità, sulla devianza per occultare non solo l’incapacità dei poteri pubblici di combattere con efficacia le nuove minacce alla sicurezza collettiva quanto piuttosto l’inadeguatezza delle amministrazioni pubbliche a garantire le condizioni e i servizi per il pieno sviluppo della persona, l’impreparazione a rispendere ai nuovi bisogni sociali, a garantire quel welfare che ha rappresentato e forse rappresenta ancora oggi il principale lascito delle Costituzioni europee del secolo trascorso, a fronteggiare la crisi del welfare indotta dalla riduzione delle risorse disponibili e dai cambiamenti della compagine sociale. Inevitabilmente gli attori pubblici concentrano l’attenzione sulla crescita dell’insicurezza per colmare la diminuzione delle prestazioni, dei servizi (sociali e non) erogati dal sistema pubblico.
Come ha ricordato il Presidente della Repubblica nel messaggio di fine anno «la sicurezza è condizione di un’esistenza serena. Ma la sicurezza parte da qui: da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune. […] La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza. Sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione per gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si realizza più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l’un l’altro». Dunque, la sicurezza si alimenta di condivisione, accoglienza ed integrazione.
Non possiamo assecondare la propensione onnivora della sicurezza. Tutto è sicurezza, nulla è sicurezza!
*Per approfondire segnaliamo il bel testo di Vincenzo Antonelli, La sicurezza delle città tra diritti ed amministrazione, CEDAM 2018.