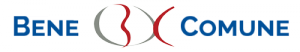Il discorso rivolto da Papa Leone XIV ai parlamentari, in occasione del Giubileo dei Governanti e Amministratori (21 giugno 2025), rappresenta un intervento di notevole spessore morale e politico. Il Pontefice non si limita a offrire una riflessione spirituale rivolta ai singoli, ma propone un’autentica visione della politica come servizio al bene comune, sollecitando un’assunzione di responsabilità collettiva e personale da parte di chi esercita il potere pubblico.
Il messaggio si articola in tre direttrici fondamentali: il primato del bene comune, la rilevanza della libertà religiosa nel contesto pluralistico e la sfida etica posta dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale. L’intera architettura del discorso si muove nel solco della dottrina sociale della Chiesa, ma al contempo si rivolge a un uditorio ampio, interreligioso e laico, ponendo interrogativi di ordine universale.
Il “bene comune” come criterio dell’agire politico
Fin dalle prime battute, Leone XIV richiama un’affermazione densa di significato: “la politica è la forma più alta di carità”, espressione attribuita a Pio XI. In questa prospettiva, la politica non è mera tecnica di governo o gestione del potere, ma vocazione a un servizio che trascende l’interesse personale o di parte. Il riferimento al “bene comune”, concetto cardine della dottrina sociale cristiana, è centrale: esso è inteso come il quadro entro cui si realizza il benessere integrale della comunità, con particolare attenzione ai più vulnerabili.
Il Papa denuncia l’“inaccettabile sproporzione” tra ricchezza e povertà, proponendo una visione redistributiva delle risorse quale strumento di giustizia e di pace. Si tratta di un messaggio di forte rilevanza politica, che chiama in causa la responsabilità dei decisori pubblici rispetto ai processi economici globali e agli squilibri interni alle società. La politica, in tale quadro, non può essere neutralizzata dalla logica tecnocratica né appiattita sull’immediatezza del consenso elettorale. Al contrario, è chiamata a operare scelte lungimiranti e coraggiose, anche controcorrente.
Libertà religiosa, legge naturale e fondamento etico dell’azione pubblica
Il secondo asse del discorso affronta un tema delicato: la libertà religiosa come diritto fondamentale e come spazio di dialogo tra culture e comunità. Leone XIV si rivolge ai parlamentari sottolineando l’importanza di promuovere condizioni che rendano possibile l’espressione pubblica del credo religioso e la sua partecipazione costruttiva alla vita civile. In questo contesto, il Papa propone un recupero della legge naturale come base condivisa per il discernimento morale, citando autorevolmente Cicerone e Sant’Agostino.
Dal punto di vista critico, tuttavia, tale posizione, pur coerente con la visione antropologica della Chiesa, solleva interrogativi nella contemporaneità pluralista: esiste oggi una base etica davvero “universale”, capace di orientare l’azione legislativa senza rischiare derive “eticiste” o imposizioni culturali? Il riferimento alla legge naturale può apparire problematico in un contesto in cui convivono differenti concezioni del bene e visioni antropologiche spesso divergenti. Tuttavia, il Papa non impone una prospettiva confessionale, ma propone una ricerca condivisa di senso, fondata su ciò che unisce piuttosto che su ciò che divide.
Intelligenza artificiale: la nuova frontiera della responsabilità
Il terzo snodo del discorso è dedicato all’intelligenza artificiale (IA), descritta come uno strumento ambivalente: da un lato promettente, dall’altro carico di rischi per la dignità umana. Leone XIV riconosce le potenzialità dell’IA nel migliorare la vita delle persone, ma mette in guardia contro l’uso disumanizzante della tecnologia. L’algoritmo, afferma il Pontefice, non può sostituire la creatività, la memoria viva e la capacità relazionale dell’essere umano. Questa visione richiama una concezione della persona come soggetto irriducibile, dotato di coscienza e libertà.
La riflessione è particolarmente pertinente, in un’epoca in cui le decisioni politiche e giuridiche rischiano di essere delegate a sistemi automatizzati, senza adeguate garanzie etiche. Leone XIV chiede ai parlamentari di farsi carico di questa sfida con “sguardo lungimirante”, promuovendo normative che pongano la tecnologia al servizio dell’uomo, e non viceversa. La politica, in tal senso, è chiamata quindi a custodire la dignità umana anche nell’ecosistema digitale.
Il discorso di Papa Leone XIV si configura come una chiamata alla responsabilità per tutti coloro che esercitano funzioni pubbliche. Lungi dal proporre soluzioni semplicistiche, il Papa offre un orizzonte di senso in cui etica, giustizia, tecnologia e spiritualità si intrecciano in un dialogo esigente. La figura finale di San Tommaso Moro – modello di coscienza, coerenza e servizio – rappresenta non solo un richiamo alla fede personale, ma un archetipo del politico come custode del bene comune, anche a costo della propria convenienza.
In definitiva, Leone XIV non propone un programma politico, ma un criterio di giudizio: la politica deve rimanere umana, orientata alla dignità dell’altro e radicata nella verità. Solo così potrà affrontare con credibilità le sfide del presente e del futuro.
Tags: Cattolici e politica Dottrina sociale della Chiesa Politica