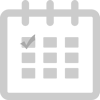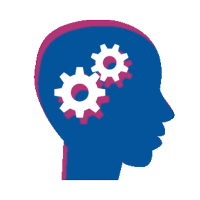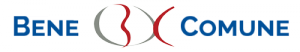Stretti tra le emergenze che la crisi ci mette davanti tutti i giorni, è naturale che attenzione e energie disponibili si concentrino su problemi di sopravvivenza o comunque di breve o brevissimo termine. Ma questo slittamento su un orizzonte sempre più limitato ed redistributivo (ripartire nel modo più equo possibile i costi della crisi) ha l’effetto di oscurare il futuro possibile e di mettere in stand by i percorsi di innovazione che potrebbero aiutare a costruirlo. Che dovrebbero comunque partire dalla crisi, ma non limitarsi ad essa.
In effetti bisogna distinguere nettamente tra due modi assai diversi di guardare ai guai del presente, Che possono essere visti in termini di crisi oppure, al contrario, in termini di transizione.
La crisi è come una malattia che ci colpisce, mettendoci a terra, temporaneamente. Perché immaginiamo che – se tutto va bene – dopo un periodo di sofferenze più o meno acute, alla fine si possa guarire e ricominciare la vita di prima. Ma questa idea, che giustifica la concentrazione degli sforzi sull’orizzonte di breve termine e sull’obiettivo della sopravvivenza immediata, presuppone che il mondo in cui si torna ad operare sia rimasto lo stesso. E che i fattori competitivi, i lavori, i redditi, le abitudini e i protagonisti del post-crisi siano non troppo difformi da quelli che esistevano in precedenza.
Solo che oggi, nel 2014, sappiamo che non è così. Quando questa interminabile depressione avrà termine, scopriremo infatti che i mercati sono popolati da nuovi competitors che hanno costi e capacità diverse dalle nostre; che i capitali e la domanda stanno andando verso altri lidi; che le nostre imprese sono abbastanza sfiduciate da non offrire occupazione addizionale in vista di incerti sviluppi futuri, per i quali bisognerebbe investire molto e assumere rischi corrispondenti. Soprattutto scopriremo che il lavoro ha cambiato ruolo, nelle filiere globali di oggi, e che una parte di esso è dentro una traiettoria di svalorizzazione progressiva si cui non si vede la fine. Mentre un’altra parte, per fortuna, conserva capacità di reddito e buone prospettive di crescita, ma solo a condizione che già oggi si facciano investimenti importanti (e rischiosi) in nuove professionalità e in nuove relazioni industriali con le imprese: due cose che la crescita dell’incertezza futura e l’incombere della crisi tende a scoraggiare.
La prospettiva della transizione, invece, è tutt’altra cosa. Essa rimanda non ad una temporanea caduta dei livelli di attività e dei margini conseguenti, ma ad un processo di trasformazione che cambia radicalmente il modo di vivere e di lavorare di tutti, passando da un paradigma ad un altro.
Il fordismo, che ha caratterizzato il secolo scorso, dominando le forme di organizzazione produttiva e del lavoro nel periodo 1900-1970, ha fissato nella storia un paradigma tecnico, organizzativo e istituzionale che fa ormai parte del passato, anche se le sue sopravvivenze sono rilevanti nella cultura organizzativa, nelle relazioni industriali, nelle norme giuridiche e nell’amministrazione pubblica.
Il capitalismo distrettuale che gli è subentrato nel periodo 1970-2000 ha cambiato il paradigma su cui modellare le forze produttive (le imprese, il lavoro, i mercati). Al posto della rigida programmazione razionale dei compiti il nuovo paradigma della flessibilità ha imposto una forma sperimentale e distribuita di intelligenza produttiva: in Italia i distretti industriali, in Giappone la lean production, negli Stati Uniti l’extended enterprise, che delega attività a fornitori esterni, organizzando catene di outsourcing. Il paradigma distrettuale dà spazio a molte piccole imprese organizzate nei circuiti di prossimità e ad una gamma crescente di specializzazioni e lavori fluidi, di tipo imprenditoriale o dipendente, basati su compiti definiti giorno per giorno e su forme di apprendimento legate alla sperimentazione pratica.
2. Vivere e lavorare nel nuovo paradigma, post-2000
Niente, però, dura in eterno. E anche le promesse del capitalismo distrettuale sono col tempo appassite. Dal 2000 in poi, questo paradigma – che pure resta nella mitologia e nelle speranze di tanti imprenditori italiani – ha perso vigore competitivo, perché globalizzazione e reti digitali hanno cambiato in modo decisivo il ruolo della prossimità territoriale. Per effetto della implosione (digitale) della distanza, le filiere produttive oggi stanno diventando sempre più estese, per sfruttare le differenze di costo, di capacità e di mercato che esistono tra i paesi del nuovo mercato mondiale. E questo ha ormai alterato la geografia competitiva delle imprese, comprese quelle del nostro paese, con rilevanti conseguenze sul lavoro.
Il vento della storia spinge ormai verso un modo di vivere e di produrre che possiamo chiamare capitalismo globale della conoscenza in rete. Un paradigma in cui la posizione di ciascuno viene definita dalla divisione globale del lavoro (nelle filiere) e dalla sua capacità di interazione con le reti di conoscenza, di lavoro e di consumo con cui ha rapporto. Il mondo, di conseguenza, sta cambiando in modo radicale, rispetto ai modelli ereditati dal novecento.
Una quota imponente di conoscenza codificata (sotto forma di scienza o tecnologia astratta, di macchine standard, di software, di apps, di codici e di procedure ecc.) è infatti diventata geograficamente mobile, per effetto della globalizzazione e delle reti digitali. In quanto tale essa viene attratta dai luoghi in cui il suo impiego è più conveniente.
Nei paesi emergenti il fattore attrattivo è il low cost, e questo alimenta lo sviluppo e la crescita del reddito (oltre che delle competenze). Nei paesi ricchi, che perdono le conoscenze e le attività low cost, i fattori attrattivi sono altri. Si investe sempre più in conoscenze generative: le conoscenze che servono per innovare o adattare le conoscenze esistenti e per stabilire relazioni complesse con altri. Si tratta di conoscenze poco codificabili, e dunque di conoscenze che rimangono ancorate alla testa delle persone e ai contesti dei luoghi che le producono. Le nuove filiere globali hanno un gran bisogno di questo tipo di conoscenze, anche per rinnovare le conoscenze codificabili che, col tempo, perdono rapidamente valore.
Dunque, chi possiede le conoscenze generative necessarie al funzionamento dell’intera filiera globale ha una rilevante capacità di “catturare” una quota non trascurabile del surplus co-prodotto nella filiera.
Su questa base, ci sono paesi che stanno già sostituendo le vecchie attività con nuove imprese e nuovi lavori basati sulla conoscenza generativa e sugli investimenti necessari per crearla e metterla in pista (istruzione, R&S, formazione, sperimentazione innovativa, autonomia e intelligenza delle professionalità utilizzate). Germania, Giappone, Stati Uniti e altri paesi come la Corea lo stanno facendo da tempo e sono a buon punto, anche se il cambiamento crea vuoti e resistenze importanti anche da loro.
In Italia, invece, abbiamo ancora troppe attività replicative, nate per imitazione o semplicemente messe in pista dal vento favorevole che tirava nel secolo scorso. Oggi queste attività stanno rapidamente perdendo peso e reddito, mentre sono ancora troppo poche le attività generative, che si collocano sulla frontiera dell’innovazione. E questo nonostante l’intraprendenza e l’originalità delle tante iniziative di successo che alimentano l’export del made in Italy, che ha retto abbastanza bene alle molte difficoltà di questi anni.
3. Dal lavoro esecutivo al lavoro generativo: la sfida dei nostri tempi
Il “terremoto” che sta cambiando la geografia della competitività ha investito il mondo del lavoro in modo assai serio e secondo linee di cui c’è ancora poca consapevolezza. Perché mentre l’ottica della crisi si focalizza sui tassi di disoccupazione (che crescono, specialmente per i giovani), l’ottica della transizione mette l’accento su ben altro.
Prima di tutto, sulla svalorizzazione progressiva del lavoro esecutivo di fabbrica e di ufficio, ossia del lavoro che si limita ad eseguire programmi o prescrizioni provenienti dall’alto (dai capi, da istruzioni codificate, da programmi). Questo lavoro è oggi in grave difficoltà perché tende ad essere sostituito sia da lavori concorrenti, situati altrove (nei paesi low cost o nei paesi ad alta capacità), sia da macchine automatiche e software che oggi sono in grado di eseguire compiti pre-programmati, anche con una certa flessibilità (purchè codificata ex ante).
Non sappiamo quanta parte del nostro sistema produttivo e del nostro lavoro rimarrà presa in questa morsa, ma non saranno percentuali piccole. Per uscirne vivi, c’è un’unica strada: collocare il lavoro e le imprese sulla frontiera promettente ma difficile, impegnativa, dell’innovazione. Non solo innovazione dei prodotti e dei processi, ma delle conoscenze, delle relazioni e dei significati che danno valore a prodotti e processi.
Sia per le imprese che per il lavoro si tratta insomma di sostituire il più rapidamente possibile i lavori esecutivi con lavori generativi, da situare in filiere globali in cui gran parte dei lavori esecutivi sono fatti altrove. Quelli che ritornano (dalla Romania o dalla Cina) sono infatti lavori generativi, che le imprese italiane riportano in patria, man mano che abbandonano l’idea di poter competere sui costi e si spostano, di conseguenza, sul terreno della qualità, dell’innovazione e dei significati.
Questo processo di trasformazione delle imprese e del lavoro richiede non solo una grande mobilità di comportamenti e forme organizzative (con nuove regole contrattuali), ma anche massicci e rischiosi investimenti nella generazione del nuovo.
4. Il lavoro auto-organizzatore richiede una nuova impresa e nuove relazioni industriali
Per i lavoratori, in particolare, significa investire tempo, denaro e attenzione ad apprendere cose che gli attuali concorrenti (rumeni, turchi, cinesi ecc.) non sanno ancora fare e che per qualche tempo ancora non sapranno come padroneggiare con rapidità e comprensione adeguata.
Significa anche cambiare lo status del lavoro in azienda, perché gli investimenti professionali da fare – essendo a rischio – sono realizzabili soprattutto su base individuale: c’è chi sceglierà di farli e chi no. Non sono configurabili come comportamenti collettivi, del tipo di quelli disciplinati dai contratti attuali (nazionali e territoriali), anche se la logica dei team può aiutare i singoli ad agire nel nuovo contesto.
Inoltre, lo sviluppo di professionalità generative richiede che il lavoro sia sempre più lavoro auto-organizzatore, in termini di autonomia, intelligenza e rischio assunto. Questo vale per i lavoratori che si mettono in proprio, o che danno vita a startups in campi nuovi; ma vale anche per i lavoratori dipendenti e le figure tecniche e manageriali che restano entro le imprese. Che, a loro volta, dovranno cambiare: l’intelligenza mono-personale al comando non basta più. Servono infatti reti produttive policentriche che, pur mantenendo un baricentro imprenditoriale di riferimento, siano capaci di sfruttare l’intelligenza condivisa e l’autonomia di decisione di molte altre unità e di molte altre persone.
Tra imprese e lavoro la transizione impone, dunque, sfide che possono essere affrontate solo applicando le energie di disponibili a progetti di innovazione condivisi, in cui gli investimenti, gli impegni, i benefici e le eventuali perdite non sono lasciati sulle spalle di questo o di quello, ma sono distribuiti secondo regole concordate ex ante. Solo così le imprese (più dinamiche) saranno incoraggiate ad andare avanti su percorsi di innovazione radicale, che diventano convenienti solo se impegni, investimenti e rischi sono condivisi con i compagni di viaggio.
E’ un percorso accidentato che, per adesso, è ancora agli inizi. Ci sono molti buoni esempi a cui ispirarsi anche nel nuovo made in Italy di cui leggiamo sui giornali. Ma, nei contesti operativi, se ne parla troppo poco e quasi mai nell’ottica della transizione.
Invece, bisogna cominciare subito a muoversi in questa prospettiva, senza attendere che la nebbia della crisi si diradi da sola: anche un lungo cammino, infatti, comincia con un primo passo.