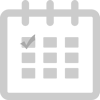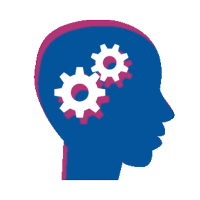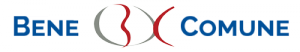Se fosse solo un gruppo sociale più o meno strutturato, pur con le collusioni e complicità di cui gode a diversi livelli, non sarebbe poi tanto difficile combatterla, ma essa è anche un’“organizzazione della mente” perché risponde in maniera efficace ai bisogni primari dello psichismo umano: il prendersi cura di sé e dell’altro, il bisogno di identità e appartenenza, per stravolgerli, però, per i propri fini criminali.
È anche questa l’intuizione che ha consentito alla ’ndrangheta di diventare un efficace strumento di potere a livello intercontinentale. Uomini e donne che hanno compreso quanto sia importante presidiare il territorio. A livello educativo l’obiettivo è educare il bambino affinché ci sia crescita senza autonomia, sviluppo senza libertà.
Perché “dire ’ndrangheta è dire anche femmina”
Nel “sistema ’ndrangheta” la donna non possiede un’identità propria. È riconosciuta in quanto “donna di…”. È lei a spingere l’uomo alla vendetta nel caso in cui venga ucciso un membro della famiglia. Alimenta la memoria del congiunto ucciso con un uso della parola e del silenzio che imprigiona i membri della famiglia dentro un eterno presente da cui è possibile apparentemente uscire solo attraverso l’agito dell’omicidio che, invece, fa ripiombare tutti dentro il passato. E ci si vendica evocando un simbolismo ben preciso: s’imbraccia un’arma da fuoco, equivalente simbolico del fallo che penetra per uccidere e non per generare nuova vita.
Un esempio: «Era stato ammazzato uno che aveva un solo figlio di circa due anni; la madre ha conservato la giacca che il padre indossava quando fu ucciso, fin quando ha potuto spiegare al figlio tutta la storia. Quando l’assassino è uscito dal carcere, è stato ucciso da questo ragazzo che indossava la giacca del padre e ha utilizzato il fucile che normalmente si tramanda come eredità di padre in figlio» (Lombardi Satriani – Meligrana, 1983).
Del figlio che si rifiuta di vendicarsi si dice «non bali e non poti» (non vale niente e non è capace). Non vi è elaborazione del lutto, ma una permanenza dentro di esso in una condizione di sospensione.
La famiglia di ’ndrangheta non è il “luogo psichico” in cui l’individuo viene aiutato a sviluppare in maniera armonica le proprie capacità e competenze, ma lo spazio in cui si apprende, con un durissimo apprendistato, a sacrificare se stessi per il bene del clan e chi prova ad uscire da questo schema va incontro non solo a disprezzo, ma anche alla morte.
Il clan costituisce quindi il “padre ideale” e, grazie all’azione educativa della madre e non solo, questa immagine paterna viene mitizzata e assunta a modello incontestabile. Contrastare il padre è andare contro se stessi, contro quello che un domani si potrà e si dovrà essere. Non è consentito nessuno svincolo, nessuna “uccisione simbolica”.
Bisogna tuttavia fare molta attenzione a non collocare la donna solo in un ruolo esclusivamente educativo. Occorre infatti distinguerne due: attivo e passivo. Nel primo caso, soprattutto quando il capo clan è detenuto, mantiene i rapporti con chi sta fuori. Nel secondo, non le è consentito manifestare un dissenso reale, neanche quando è in gioco la vita dei figli. Tutto questo è incomprensibile se non si tiene conto del fatalismo con cui queste donne accettano il proprio mondo come l’unico possibile. Anche se negli ultimi anni ci sono state scelte coraggiose di alcune donne che, purtroppo, hanno addirittura pagato con la morte questo loro desiderio di “emancipazione”. Un nome per tutte, Maria Concetta Cacciola.
Cosa fare?
A volte per arginare per tempo dinamiche educative che si ripetono, va perseguita la strada coraggiosamente imboccata di sospendere la patria potestà e affidare i minori ad altri “soggetti educativi”. ’Ndranghitisti non si nasce, si diventa!
Nello stesso tempo occorre agire per costruire un “senso ampio di comunità” che faccia da supporto alla costruzione di un’“identità aperta”; alla diffusione di un senso di solidarietà che travalichi i legami di parentela e amicizia. Il metodo da privilegiare è il “lavoro di comunità e di rete” attraverso interventi nei processi di educazione e socializzazione primaria e secondaria (sostegno alla genitorialità, alla scolarizzazione dei minori) e in ambito psicoterapeutico ove è necessario e possibile. E interventi nel campo dell’animazione socioculturale all’interno dei quartieri; inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro. In sintesi è necessario “riconquistare” le piazze e le strade.
Per finire, affidarsi esclusivamente alla repressione giudiziaria significa aver perso in partenza la lotta contro le ’ndrine. Ci sono infine due presupposti da tenere ben presenti: non pensare la ’ndrangheta come qualcosa del tutto aliena dal proprio modo di pensare; e fare i “cavalieri solitari”. A ciascuno scegliere da che parte stare. A Reggio Calabria come a Roma; a Milano come a Bogotà… Tertium non datur, almeno in questo caso.