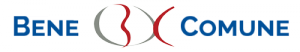La vicenda giudiziaria, invero, seppur conclusa nel caso specifico, ha dato origine ad un contrasto con altra sentenza della Cassazione, il quale sarà probabilmente oggetto di una pronuncia delle Sezioni Unite. Vedremo.rn
In questo quadro, non ha per me molto interesse una discussione sui contenuti specifici della sentenza, né sulla correttezza argomentativa della Corte, né infine sulla congruità della decisione con le norme vigenti in materia. Come detto, siamo ancora in mare aperto, la stessa giurisprudenza mostra troppi contrasti al suo interno, ed è prudente aspettare, prima di commentare, e vedere quale sarà l’orientamento indicato per l’appunto dalle Sezioni Unite.
Quello che più mi interessa, e che ha rilievo culturale, oltre che strettamente giuridico, è il modo di concepire il fenomeno migratorio e le dinamiche di integrazione che emerge da questa sentenza, oltre che più in generale da gran parte della normativa vigente. E’ un modo che non esiterei a definire individualistico e, in una certa misura, hobbesiano.
L’idea infatti che continua a stare alla base della normativa sull’immigrazione è che essa sia un fenomeno che coinvolge l’individuo, il singolo soggetto che, in cerca di lavoro e condizioni di vita migliori, sceglie di migrare. Ed inoltre, che l’integrazione nella comunità di arrivo sia ancora una questione tutta individuale, una relazione verticale fra detta comunità (lo Stato italiano, ad esempio) ed il singolo che chiede di poter restare, lavorare, godere di certi diritti, ecc…; in questa prospettiva, la questione si risolve nel riconoscimento di certi diritti in capo al singolo, riconoscimento che può culminare nell’attribuzione della cittadinanza, o viceversa nella decisione di espellerlo in quanto irregolare.
Ora, credo che il primo di tali presupposti sia del tutto sbagliato, e che il secondo debba essere per conseguenza superato da un approccio non più centrato solo sull’individuo, ma sul contesto relazionale.
La migrazione, anzitutto, non è una vicenda individuale. Disponiamo già di numerose ricerche (fra tutte: E. Scabini – E. Rossi, La migrazione come evento familiare, Vita e Pensiero 2008) che dimostrano come da nessun punto di vista il fenomeno migratorio sia comprensibile come fatto esclusivamente soggettivo. La decisione di migrare, e l’intera vicenda migratoria, coinvolgono l’intero sistema delle relazioni soggettive, ed in particolar modo la famiglia; anche se è un singolo individuo che affronta i rischi e le fatiche del viaggio, a migrare è in qualche modo tutto il contesto relazionale nel quale vive, e la famiglia in particolare: è la famiglia che decide chi, quando e dove migrare, ed è sempre la famiglia il riferimento primario della migrazione. Il sistema delle rimesse, a sua volta studiato a fondo, non è il frutto della decisione ammirevole e benevolente dei singoli, ma la conferma di un legame perdurante tra il singolo migrante e il sistema di relazioni che ha dato origine alla dinamica migratoria. Insomma, non migra mai un singolo individuo, ma un intero sistema relazionale che ha al suo centro la famiglia, ma che si estende spesso ben al di là di essa.
Ecco allora perché, ed è questo il secondo punto, risultano inefficaci e starate tutte le discipline che non tengano conto di questa realtà, e che per contro abbiano come proprio oggetto esclusivo la posizione del singolo migrante. Del resto – ma il discorso meriterebbe di essere infinitamente più complesso – è tutto il paradigma della cittadinanza, per come elaborato almeno a partire da Hobbes, ad essere pensato in chiave strettamente individualistica. Siamo abituati infatti a pensare che la cittadinanza, ed il sistema dei diritti che ne consegue, siano lo specchio di una relazione verticale fra il singolo e la comunità; e l’intera comunità, in qualche modo, è ridotta ad un insieme di singoli cui lo Stato attribuisce diritti e dei quali riconosce le spettanze, ed il complesso sistema delle relazioni sociali (familiari, associative in generale, ecc…) non è che la conseguenza dell’esercizio da parte dei singoli dei loro diritti individuali.
Questo schema – che, mi rendo conto, ho delineato fin troppo rapidamente – è quanto mai inadeguato a gestire la complessità del fenomeno migratorio. Sia perché non sa cogliere quella dimensione familiare in cui, come detto, esso invece consiste, sia perché non è in grado di gestire la dimensione culturale del fenomeno stesso.
L’idea che una famiglia possa essere smembrata perché uno dei suoi componenti non è in regola, non ha il permesso di soggiorno, è la riprova di quanto il nostro sistema misconosca la dimensione relazionale della migrazione; è la conferma, insomma, del fatto che continuiamo a pensare la migrazione, e in generale l’integrazione comunitaria, come un fatto che coinvolge i singoli, che di volta in volta hanno o non hanno i requisiti necessari per integrarsi. Si tratta sempre di quel paradigma che risolve tutta la dimensione comunitaria nell’insieme dei vincoli che uniscono i singoli allo Stato (ma si può dire, se si preferisce: alla comunità in senso astratto, o al sovrano), e che trascura o mette in secondo piamo la realtà dei sistemi relazionali nei quali i singoli sono inseriti.
Ecco allora l’ulteriore rischio (anche qui, evidentemente, pago la sinteticità con la superficialità) di non essere in grado di disciplinare la rilevanza culturale del fenomeno migratorio. Perché infatti la migrazione non solo ha una dimensione relazionale d’origine, ma anche di arrivo; il migrante non si presenta mai come un singolo che chiede di integrarsi in una comunità nazionale, ma come parte di un sistema relazionale che, nel suo complesso, chiede di essere riconosciuto. Il fenomeno, anche qui, è noto e studiato: la migrazione genera nuove comunità, che si integrano e si generano per dinamiche di appartenenza culturale, religiosa, etnica, linguistica, e così via, e che chiedono di essere riconosciute di per sé. Il migrante non è mai solo (se si eccettuano i migranti d’élite, professori e scienziati e manager…), ma ricostruisce la propria identità all’interno di un sistema di relazioni che comprende la comunità ospitante, e soprattutto il gruppo culturale etnico religioso nel quale si radica.
Ora, anche in tal caso un approccio individualistico non riesce a dare risposte adeguate a questa realtà, proprio perché manca il bersaglio. In un paradigma di cittadinanza centrato sull’individuo, che rilevanza può mai avere l’appartenenza culturale? Come gestire, da questa prospettiva, una realtà, come quella etnica o religiosa o linguistica, che per contro è specificamente relazionale?
La sociologia (e non c’è bisogno di richiamare il lavoro prezioso di Donati), la psicologia, la scienza economica hanno da tempo cominciato a prendere sul serio questa dimensione relazionale; i giuristi, mi sembra, sono rimasti un po’ indietro.
rn