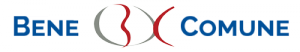Abbiamo alle spalle mesi segnati da una precarietà che è entrata prepotente nelle case e ha attraversato la vita di tutti noi. Le campane suonate a morto, le sirene delle autoambulanze, i tanti, troppi, lutti. In brevissimo tempo, nella nostra comunità bergamasca, sono venute a mancare figure comunitarie, persone che hanno reso bella la vita dei nostri territori Sacerdoti, medici, infermieri, insegnanti, volontari della protezione civile, alpini, allenatori, pittori, fornai, sindaci, animatori dell’oratorio, maestri di canto, esperti di presepi, cooperatori, catechisti e tanti altri. Se ne è andata, brutalmente, una generazione di donne e uomini che hanno costruito ponti, creato legami, cucito relazioni. In tempi di conclamata disintermediazione, sono persone che fino all’ultimo hanno continuamente tessuto dal basso le ragioni dello stare insieme, hanno avuto cura dell’altro e del mondo abitato e custodito il “noi” come antidoto alla solitudine di tanti e come ricetta per una vita buona e generativa.
La morte nascosta
Eravamo abituati a nascondere la nostra precarietà e vulnerabilità nel privato, come se riguardasse gli altri e non noi o, viceversa, noi e non gli altri. Pensavamo di aver addomesticato la morte spettacolarizzandola o nascondendola allo sguardo e, invece, in poche settimane abbiamo brutalmente imparato che esiste una dimensione comune della vulnerabilità e della fragilità. Quelle bare dei morti sui camion, esposte alla vista di tutti, sono state una tragica esperienza collettiva che ha frantumato la pretesa onnipotenza del nostro tempo. Bare su camion militari, senza la presenza di persone amiche. E’ stato l’epilogo di tanti, morti da soli, in isolamento. Non vi è stato il tempo di un saluto, di un cambio di abito, di una sepoltura, per chi lo desiderava, nella terra. Solo la consegna, ai parenti, dell’urna con le ceneri.
Tempo per ricucire
Servirà molto tempo per rielaborare questa ferita aperta. Serviranno occasioni per trovare parole giuste, dare forma ai silenzi, non lasciarli inespressi. Servirà ragionare attorno a questi temi e riportarli dentro la riflessione pubblica perché, se pure a volte lo dimentichiamo, essi intrecciano prepotentemente vita e morte. Che non sono mai separati. Solo un’ossessionata e spasmodica attenzione alla vita, frutta di una difficoltà a fare i conti con quella che si ritiene essere la sconfitta della morte, può ritenere che valga di più vivere che le ragioni per le quali si vive. I martiri di ogni tempo e di tutte le fedi hanno dimostrato il contrario. E’ importante vivere ma ancor di più sapere perché e per queste ragioni essere perfino disposti a perdere l’esistenza.
Se non vita, non è cristiana
Anche noi cristiani saremo chiamati a fare la nostra parte cercando, senza arroganze, di dare forma evangelica alle esperienze fondamentali della vita, mostrandoci capaci, più di quanto abbiamo fatto sinora, che il vangelo è occasione di elaborazione di senso. Per tutti, credenti e non credenti. Perché la vita cristiana se non è vita non è neanche cristiana. A far crescere, giorno dopo giorno, e non astrattamente, il senso di comunità. In questi mesi abbiamo capito quanto sia astratta l’idea di individualismo. Siamo tutti dentro una fitta rete di legami, di connessioni. Le nostre vita, i nostri territori, la nostra economia. Nessuno può farcela da solo. Ciascuno deve sentirsi responsabile di tutti. Lo abbiamo avuto ben presente nei mesi scorsi. Sarà decisivo nei prossimi mesi dove saremo messi a dura prova. E poi ragionare più a fondo su un sistema sociale che pareva avere come fine il business e non il bene comune, su una politica capace di valori e di competenza. Non solo di slogan.
Riprendere a fare domande
Avevamo smesso di farci delle domande. Abbiamo dato per scontato che si potesse convivere con l’insostenibilità di un sistema che non reggeva più a livello ambientale, economico, culturale. Il tempo che abbiamo di fronte – il post coronavirus – può essere davvero un nuovo inizio solo se saremo capaci di sentirci parte attiva e critica di un mondo che non può più solamente essere misurato da una crescita che si è rivelata insostenibile per la vita delle persone e della terra. Cinque anni fa, con lucidità, ce lo ha ricordato la Laudato Sii di papa Francesco: tutto è connesso. Solo guardando il mondo a partire dai più poveri e dai più vulnerabili, mettendo al centro le persone in carne ed ossa, sarà possibile fare di questa crisi un’opportunità. Altrimenti sarà solo retorica. Credo che una virtù da custodire in questo nuovo inizio sia quella dell’indignazione. Che è la capacità di non rassegnarci a ciò che è ingiusto, di non accettare più l’inaccettabile. Anche se ha il consenso dei più. E’ il primo passo per ogni azione personale e per ogni scelta politica.
A proposito della Sanità
Prendiamo il caso della Sanità lombarda. Nei mesi trascorsi abbiamo provato sentimenti di profonda gratitudine nei confronti dei moltissimi operatori sanitari, medici e infermieri, che hanno vissuto, con assoluta dedizione la straordinarietà della situazione. La gran parte di loro ha svolto turni lunghi, senza ferie né permessi, con gravi rischi di contagio. Hanno dimostrato, nonostante tutto, la qualità della Sanità pubblica. Nonostante tutto, perché questa è stata fatta oggetto, negli anni precedenti, di denigrazione e tagli continui. In Lombardia abbiamo ridotto i presidi territoriali, gli ambulatori e i consultori, caricato di assistiti i medici di base, diminuito i posti letto per la terapia intensiva. Si è gestita la sanità come fosse un’impresa come tutte le altre e dunque sottoposta alla legge dei costi e dei benefici: se un investimento non rende nei tempi e nei modi del capitale, non si fa. Dalla metà degli anni Novanta a oggi, i posti-letto pubblici della Lombardia sono stati dimezzati, mentre quelli privati aumentavano in proporzione. Le strutture di ricovero pubbliche e private ormai si equivalgono per numero: da noi a Bergamo prevalgono anzi quelle private. Insomma, dopo l’emergenza sarà necessario ragionare a lungo su un modello economico che non è stato capace di reggere e che si è dimostrato estremamente vulnerabile.
Per ricominciare
Due mi sembrano gli elementi decisivi per ricominciare: la condivisione solidale, necessaria per venirne fuori; e l’esercizio di una responsabilità personale. Se riusciremo a crescere, almeno sarà venuto un frutto da questa vicenda terribile. A ciascuno di noi è chiesto di far propria la lezione di questi ultimi mesi: sentirsi parte di una comunità di destino planetaria, più grande del perimetro nazionale. In un mondo globalizzato, complesso, interconnesso ogni piccolo evento locale può avere conseguenze su scala mondiale. Nel male come nel bene. Per questo servono nuovi paradigmi che ci portino ad accettare la complessità del mondo. Lo sapevamo anche prima, forse lo abbiamo ripetuto più volte quando parlavamo di Hiroshima e di pace, di ambiente e di Amazzonia, ma facevamo fatica a crederlo. Ce lo ha ricordato invece con lucidità papa Francesco la sera della benedizione Urbi et Orbi: “Da settimane sembra che sia scesa la sera… presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati… ma tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti.”.
Prima di tutto questo, dalla mie parti c’era chi parlava di confini presidiati e di frontiere chiuse. E’ arrivato un virus che non ha chiesto permesso a nessuno. Per vincerlo sono arrivati da noi medici russi e cubani, cinesi e albanesi. Perché il Covid ha frantumato il mondo ma lo ha anche rimpicciolito. E ci fa sentire tutti più vicini. Vorrei tanto che non lo dimenticassimo, quando tutto sarà finito.
Tags: Covid-19 Cristianesimo Papa Francesco sanità