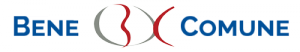La geopolitica del Mondo sta rapidamente mutando i rapporti di forza
In un Mondo in perenne evoluzione, da alcuni decenni e fra i grandi competitori globali, si è progressivamente affermata una fase accelerata di transizione verso nuove gerarchie. Senza che sia riconosciuto in tutte le sue numerose e variegate manifestazioni, è in atto un massiccio mutamento nei rapporti di forza fra le principali potenze politiche ed economiche del pianeta e, a cascata, nella composizione e nella estensione delle rispettive aree di influenza. Nel 1989, con la caduta del muro di Berlino e il dissolvimento dell’impero sovietico, si sono frantumati gli accordi di Jalta e da allora, nel quadro politico mondiale, sono intervenuti numerosi altri cambiamenti. Nulla di nuovo sotto il sole: la storia dei sistemi politici è prodiga di ascese irresistibili e di rovinose cadute. Ciò che rende diverso il presente dal passato è, da un canto, la repentinità dei rivolgimenti mondiali: pochi decenni sono sufficienti a sovvertire un ordine apparentemente stabile e duraturo. Dall’altro, la constatazione che di questi mutamenti gli artefici non siano soltanto strutture territoriali come Stati o Nazioni ma, in misura crescente, sono entrati nel gioco altri soggetti. Il riferimento corre alle potenti imprese multinazionali, portatrici di enormi interessi economici, ai grandi organismi sovranazionali, con i loro obiettivi specifici, statutari, di natura militare, regolatoria, per lo sfruttamento delle materie prime, ad altri potentati. Sul crescente ruolo sia delle prime che dei secondi, in questa sede non verranno spese considerazioni specifiche cadendo, le rispettive linee di comportamento, fuori dall’area concettuale di questo contributo.
Queste considerazioni introducono a qualche prima, interessante, annotazione, ossia a come la ricchezza, il potere nel Mondo, nonostante l’allargamento della platea dei soggetti giuridici coinvolti, siano sempre più concentrati in un numero minore di mani. Analisi anche recenti hanno mostrato come all’aumentare del reddito complessivo la curva di Lorenz-Gini tenda ad allontanarsi ulteriormente dalla bisettrice. Una delle ragioni sta nel fatto che è in calo la quota di potere esercitato da organismi in qualche modo legittimati dalle popolazioni e dai rispettivi elettorati.
Nella gestione concreta delle strategie politiche, da una netta prevalenza della sfera pubblica (gli Stati) si assiste ad un crescente ruolo del privato (imprese in primo luogo, ma poi fondazioni, associazioni e via dicendo). Il fenomeno, di natura geopolitica, ribatte una situazione già presente in economia, ossia è in atto una progressiva concentrazione della ricchezza e del potere economico presso un piccolo numero di soggetti. Grandi accumulazioni capitalistiche e diffusione della povertà anche fra i ceti medio-bassi provocano un massiccio incremento degli squilibri economici e sociali. Sono i meccanismi della geoeconomia che stanno colonizzando la geopolitica: le dinamiche economiche soffocano quelle politiche. È il lato oscuro di Società che non hanno saputo o voluto darsi delle regole etiche e hanno contrabbandato come filosofia liberista la prevaricazione del ricco sul povero; delle classi al potere rispetto a quelle subalterne. È l’economia, e la finanza in modo più specifico, che soverchia la politica, ne prevarica gli obiettivi e ne limita il suo spazio di manovra. Allo stato attuale è una tendenza irreversibile e, di fatto, incontenibile. E non è certamente la strada che porta ad un riequilibrio complessivo e a un benessere diffuso fra le popolazioni del Globo e se, ad oggi, non esiste alternativa a questi processi di crescita economica allometrica, conoscerne il funzionamento rappresenta, comunque, un primo passo per immaginare e lavorare ad una realtà diversa. Una realtà nella quale la politica recuperi il ruolo di difensore dell’etica, di propugnatore dell’equità sociale, di mediatore ideologico.
Una seconda considerazione riguarda le forme attraverso le quali i maggiori potentati mondiali si fronteggiano. In prima battuta si può osservare come elemento cardine della competizione internazionale sia costituito dalle dimensioni del mercato: la “trippa” per i piccoli è molto risicata e, nell’agone globale, non vale il principio che “piccolo è bello”. Infatti, non è certamente per caso che i primi due Paesi in concorrenza per la supremazia mondiale siano gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Popolare di Cina. E se gli USA hanno nel reddito prodotto il loro punto di forza (oltre 76.000 dollari pro capite nel 2023 per quasi 335 milioni di ab., secondo le stime della Banca Mondiale), la Cina contrappone un enorme potenziale demografico (1,42 miliardi di ab., con un reddito pro capite PPP poco superiore ai 26.000 dollari).
Il ruolo degli altri Paesi non è di semplice “tappezzeria”, ma è certo che, per le evolute, mature, economie del XX secolo, il loro peso si è progressivamente ridimensionato. Germania, Giappone, Regno Unito, Francia e anche Italia negli anni Sessanta e Settanta soverchiavano la Cina e occupavano le prime posizioni di rincalzo, ma con il trascorrere del tempo, il ridimensionamento dei loro ritmi di crescita, a fronte di una inusitata crescita dell’economia cinese, ha finito per penalizzare le percentuali del loro contributo all’economia globale. A rimpiazzarli sono, nuovamente, Paesi con mercati importanti, tecnologicamente attrezzati e in costante accrescimento. Si tratta di Stati un tempo considerati emergenti, ma il loro turno è arrivato e India, Brasile, Russia, Messico, Sudafrica sono in corsa per sostituirsi nell’occupare le posizioni a ridosso dei primi. Era, ed è, un fatto ineluttabile, in parte conseguenza delle ridotte dimensioni dei mercati europei, ma dovuti anche alla concomitanza di altre ragioni (demografiche, in primo luogo, ma anche politiche e non solo). Ad oggi, l’unica possibilità di contrastare il consolidamento della struttura dualistica alla testa dell’economia e della politica mondiale e per contare di più sul proscenio globale era, ed è, legato alla crescita, in termini sia politici come economici, dell’Unione Europea. Ossia di un soggetto politico unitario, sovrano, legittimato, che sul piano delle dimensioni, della coesione, della competitività dei valori di riferimento possa reggere il confronto con i due grandi leader mondiali: Stati Uniti e Cina.
Accanto a USA e Cina, un ruolo anche per l’UE?…
La possibilità che l’Unione Europea riesca ad inserirsi nel grande gioco dell’economia e della politica globale non è scontata. Infatti, se la Cina e gli USA, negli ultimi decenni, hanno sviluppato caratteristiche vincenti, non altrettanto si può affermare della UE. La ragione sta nel fatto che la competizione globale avviene fra grandi sistemi integrati, connotati dal possedere la capacità di imporsi sui contendenti (che si esprime attraverso una “forza” intrinseca: politica, economica, militare, organizzativa, tecnologica: in una parola, competitiva) a cui si aggiunge una spiccata coesione interna. Sistemi più coesi sono sistemi più efficienti, più competitivi. Gli esempi più probanti sono rappresentati dalle imprese multinazionali o dai Paesi con un regime autoritario. Essi sviluppano la loro azione istituzionale in tempi più rapidi, in quanto è molto semplificato il processo per la costruzione delle decisioni.
In virtù dei differenti livelli coesivi, esiste una asimmetria funzionale, che ha rilevanti conseguenze politiche in quanto i soggetti monocratici operano con maggiore flessibilità e tempestività dei sistemi democratici, non di rado imbalsamati da normative regolatorie rigide e penalizzati dall’affermarsi di correnti di pensiero eterogenee, quando non contrapposte. Ciò che più conta, l’emergere di questi nuovi interlocutori avviene in un contesto post-ideologico e quindi essi si affacciano sul palcoscenico politico svincolati da schieramenti dottrinari e da vincoli etici. E in questa corsa alla supremazia globale e vista la massiccia incidenza degli obiettivi economici, che tendono a prevalere su quelli sociali, non di rado accade che gli aspetti etici quali la sostenibilità ambientale o i concetti morali relativi alla persona e alla dignità umana siano percepiti come degli ostacoli che si frappongono alla capacità di competere e siano relegati in subordine, con buona pace dei principi dell’umanesimo integrale. Se nel mondo dell’impresa, allorché si parla di innalzamento della produttività, il pensiero corre immediatamente al costo del lavoro e non agli investimenti in tecnologia avanzata o in evoluti modelli organizzativi, c’è una ragione. Che va rimossa, in quanto la manodopera non può essere considerata come uno dei fattori del costo del prodotto; dietro ad essa, infatti, insistono valori inalienabili, in Italia garantiti dal dettato costituzionale.
Va poi ricordato che i grandi sistemi integrati sono, per loro natura, strutture complesse, a volte molto complesse. Se, da un lato, questa è l’espressione di una massiva interazione fra gli operatori, e quindi di uno dei caratteri che esprimono la “forza” del sistema, la sua capacità di competere e di affermarsi, dall’altro lato, nelle strutture ad ampia partecipazione alle decisioni, la complessità esprime anche una pluralità di stakeholders. Con l’aumento degli interlocutori si incrementa la variabilità delle loro finalità primarie e ciò può causare un incremento netto nei tempi e negli sforzi per far convergere verso obiettivi comuni interessi per loro natura contrastanti, quando non contrapposti. E, di nuovo, il pensiero corre all’UE e alle sue modeste strategie per la creazione di un mercato unico e di un solo soggetto politico.
Può accadere, infatti, che sistemi complessi perdano di coesione e le forze interne invece di cooperare al raggiungimento di obiettivi comuni, si fronteggino, si scontrino: allora il sistema è a rischio di frammentazione e di disarticolazione. Di solito sono prodromi del declino sistemico, in quanto la struttura portante perde solidità, efficienza, complessità, fino al punto di generare al suo interno la formazione di componenti antisistema. Tutto a scapito della forza competitiva, del portato ideale, della struttura organizzativa. Un percorso noto ma che, nonostante siano ben conosciute le conclusioni del processo regressivo, cionondimeno la tendenza autodistruttiva -quando compare- viene perseguita con caparbietà.
Una piccola considerazione a latere: nei sistemi a maggiore complessità, la velocità con la quale gli organi di gestione prendono consapevolezza dell’esistenza di un problema è superiore a quella che consente ai sistemi politico-sociali di mettere a punto strategie in grado di risolverlo. La tecnologia è in grado di minimizzare, fino ad annullarli, i tempi in cui viaggia l’informazione. Se ne deduce come siano ben altri i tempi necessari alla messa a punto delle strategie ad hoc. Emblematica, in proposito, è la lotta al global warming, forse la principale sfida che l’Umanità deve affrontare dalla sua comparsa su questa Terra e provocata da secoli di sfruttamento delle risorse energetiche fossili. L’utilizzazione del carbone, del petrolio, del gas naturale se sono all’origine dello straordinario processo di crescita e di diffusione del benessere economico per alcune Grandi Aree del Globo, stanno però causando danni pressoché irreversibili al sistema Terra. Il processo di accumulazione dell’anidride carbonica ha raggiunto valori critici e affrontare una tale emergenza è tutt’altro che semplice, non tanto sul versante tecnologico -complicato, ma sul quale soluzioni sono praticabili- quanto su quello politico, per l’esigenza di mettere a punto un consenso condiviso. Gli interessi in gioco sono immensi, sono contrastanti, non sono solo economici anche se questi ultimi sono di gran lunga prioritari.
…sì, ma a condizione che aumenti la coesione di sistema
Se questo è il contesto, allora la quadratura del cerchio richiederebbe un inaudito sforzo comune, una grande alleanza fra gli attori globali, meglio se fra tutti: Stati, multinazionali, organismi di varia natura assieme per una causa comune. Ma, come si è visto, gli interessi in gioco potrebbero essere molteplici e disomogenei. E se, come accade, sull’ipotetico tavolo di contrattazione globale, siedono interlocutori con alle spalle sistemi politico-economici dotati di differenti livelli di persuasività, è nella natura delle cose che prevalgano le istanze portate dagli interlocutori più forti. Eventuali soluzioni prospettate dai deboli possono essere ritenute sacrificabili o, in una ipotesi benevola, rinviabili a tempi migliori. Da questa considerazione si ricava che, nel caso di partecipanti deboli, il primo obiettivo che questi debbono porsi non è tanto quello di rivendicare proprie strategie, quanto quello di puntare al rafforzamento della propria posizione per sedere con una maggiore autorevolezza al tavolo della contrattazione. Il discorso riguarda in primo luogo l’Unione Europea che, innanzi tutto ha poteri strategici dimezzati, dispersi fra ininfluenti sovranità nazionali quando (es. il global warming) sarebbe richiesto una grande coesione politica, espressa da unico centro decisionale o, quantomeno, da una cabina di regia unificata; in secondo luogo, il sistema di regole preposto alla formazione delle decisioni è divenuto lento, farraginoso e inutilmente complicato, con grave pregiudizio della efficacia delle azioni intraprese. Come esperienze anche recenti dimostrano, le priorità logiche da osservare (coesione) non riscuotono grandi successi, pur dimostrandosi la via più lungimirante per far valere le proprie ragioni e ottenere risultati concreti. Prevalgono controproducenti comportamenti “di bottega” che poco aiutano l’UE a rafforzare sul piano globale la propria immagine e le proprie potenzialità di intervento.
Per tornare ai contenuti economici della geopolitica, va considerato che i problemi del Mondo hanno, e hanno sempre avuto, rilevanze territoriali diverse e, conseguentemente, si svolgono in modo parallelo e agiscono su piani diversi. Riconoscere questi piani significa individuare correttamente gli obiettivi da perseguire, la loro gerarchia e, a cascata, le priorità da osservare nella elaborazione delle relative politiche. Nonostante la presenza di piani diversi richieda interventi diversi è indispensabile mantenere coerente e unificato il sistema decisionale, per non incorrere nel rischio che singoli provvedimenti, quando non intere strategie, siano fra loro contrastanti. Ai fini puramente pedagogici, è opportuno recuperare il concetto di “scala geografica” (quindi del rapporto che lega la superficie reale con le dimensioni della sua rappresentazione) e della struttura gerarchica che ne scaturisce.
L’UE è carente di strategie globali credibili a causa della sua persistente frammentazione politica ed economica. La scala geografica come strumento logico di inquadramento
Al vertice della piramide del rapporto fra superfici reali e la loro rappresentazione grafica si trova la scala piccola o piccolissima (ossia con un rapporto di riduzione dell’ordine di 1:15 – 1:20 milioni. Un cm sulla carta corrisponde a 15-20 milioni di cm sulla superficie terrestre). La cartografia che ne scaturisce (i planisferi) è in grado di contenere, di rappresentare in modo comprensivo, soltanto fenomeni globali, planetari, al massimo continentali. Si pensi, ad esempio, al citato global warming, ai suoi effetti, agli incrementi di temperatura degli oceani e dei mari di tutto il mondo: il fenomeno è globale e la sua rappresentazione complessiva non può che essere a questa scala.
I fenomeni globali richiedono risposte globali e, pertanto, in termini di efficacia, la messa a punto di interventi in grado di incidere su tali fenomeni non può prescindere dal fare i conti con i maggiori produttori di CO2, non a caso Cina (11,5 miliardi di t nel 2023) e Stati Uniti (5 miliardi di t). Questo comporta che se, singoli Paesi, come Italia (0,3 miliardi di t) o Francia (0,3 miliardi di t), Germania (0,6 miliardi di t) o qualsiasi altra regione del Globo nel quale si sia affermata una sensibilità ambientalista si accordassero per decarbonizzare i propri consumi energetici, i loro sforzi avrebbero comunque un ridotto impatto globale in quanto il fenomeno si svolge altrove e ad un livello superiore, ad una scala più piccola. Quindi, si tratterebbe di provvedimenti importanti sul piano dell’immagine, ma poco rilevanti su quello degli effetti diretti.
Al riguardo, non va poi trascurato la presenza di un altro rischio, ossia di cadere in un errore di valutazioni politiche: trasferire su un più comodo piano ideologico problemi e rivendicazioni che, viceversa, hanno un preminente contenuto tecnologico e nel quale la ricerca e la sperimentazione non hanno ancora raggiunto soluzioni tecniche definitive. Iniziative come quella di indicare, nell’ambito del cosiddetto Green Deal della UE, un termine abbastanza ravvicinato come il 2035 per la fine programmata delle autovetture endotermiche, ha avuto pesanti ricadute geoeconomiche e geopolitiche: una misura scarsamente ponderata e assunta sotto la spinta di ortodossie politiche piuttosto che di un equilibrato ragionamento economico e di obiettivi industriali. Accade che l’industria meccanica europea rischia di essere smantellata con impensabili ricadute sull’economia dell’intero continente. Infatti, se da un canto le aziende produttrici di queste autovetture hanno tempi limitati per progettare e adeguare le filiere industriali ai nuovi prodotti, dall’altro ciò che si verifica è la sostituzione della dipendenza dai Paesi produttori ed esportatori di petrolio con una altrettanto pesante dipendenza dai Paesi produttori ed esportatori di batterie. Il tutto per trovarsi poi nella necessità di incentivare l’acquisto di autovetture elettriche, per le quali il mercato non sembra particolarmente entusiasta.
Superando le situazioni anche critiche che si vengono a creare allorché interlocutori di seconda o terza linea desiderano far valere le proprie ragioni sul mercato mondiale, va ribadito che gli unici, veri e concreti interlocutori sui temi globali sono gli operatori globali: i citati USA e Cina. La frantumazione dell’impero sovietico ha privato la Russia l’appartenenza a questo club e al quale il Paese tenta forzatamente di rientrare, anche con operazioni disinvolte e a volte molto discutibili. La stessa UE, senza una strategia unificata con un centro decisionale unico, sta attraversando una fase di profondo declino geopolitico e già appartiene alla schiera dei nobili decaduti. In fase di crescita è l’India (già 2,7 miliardi di t di CO2 immessi nell’atmosfera) che, in conseguenza anche del suo enorme potenziale demografico, si appresta a divenire il terzo interlocutore globale. Qualche interferenza sulla piccola scala proviene poi dalle emergenti categorie di stakeholders: da strutture associative politiche come i Brics o la Lega Araba; dall’associazionismo specialistico, come Nato, Opec; dalle varie agenzie dell’ONU, ecc. Per l’UE contribuire a battere il global warming implicherebbe tenere entrambi i piedi nel novero degli interlocutori globali: l’ostacolo è, però, rappresentato dalla presenza di forze antisistema, dalle pulsioni sovranistiche (che, in questo esempio, commettono un evidente errore di scala, associato ad una prevaricazione ideologica sul portato tecnico) che, agendo all’interno dell’Unione, ne indeboliscono ruolo e forza, provocando una perdita secca di capacità rappresentativa e di interlocuzione sistemica.
La scala di teatro come cartina di tornasole: il caso della filiera logistica
La mesoscala va da 1:3-5 milioni a 1:15-20 milioni. È la tipica scala di “teatro”: si sviluppa su più Stati e abbraccia intere “aree problema”. Esempi tipici sono il Vicino e Medio Oriente, l’Africa Saheliana, il Sud-Est asiatico, e via dicendo. Non si tratta di aree “omogenee”, di grandi regioni in qualche modo coese, bensì di classi areali, di territori messi assieme solo in ragione della vicinanza geografica. Non di rado scomodi vicini con i quali è più facile scambiare colpi di cannone piuttosto che capitali, merci o servizi. È la scala alla quale sono ascrivibili i principali conflitti armati che insanguinano i popoli della Terra e sulla quale interlocutori globali e semiglobali si confrontano più o meno direttamente. È, nel contempo, la scala alla quale operano molte strategie-Paese e dove si concretizzano alcune delle politiche nazionali per la competizione globale.
L’esempio a noi più vicino di mesoscala è la regione mediterranea, l’area che comprende tutti i Paesi rivieraschi di quello che i Romani definivano come mare nostrum e che, per le sue peculiarità geopolitiche, ben si presta a qualche considerazione esemplificativa. Così, tornando al tema del global warming, una delle conseguenze connesse all’innalzamento delle temperature degli oceani è rappresentato, per il Mediterraneo, dall’invasione delle specie aliene. Pesci, molluschi, crostacei caratteristici dei mari tropicali che, a causa del patologico aumento delle temperature delle acque, si stanno diffondendo nei mari della sponda sud dell’Europa. Ne sono derivati grandi problemi per la pesca, l’allevamento, l’alimentazione, gli equilibri faunistici ed è evidente che il ripristino degli antichi equilibri significa riportare le temperature del mare entro i limiti storici e fisiologici. Si tratta della lotta al global warming, proprio quella che vede con le armi spuntate l’UE, ma di questo già ci siamo occupati. In attesa di un accordo concreto, sostanziale fra gli inquinatori globali, singoli Paesi o, forse, gruppi di essi, possono sentire l’esigenza di intervenire, di fornire il proprio contributo alla causa comune. Nella impossibilità di interferire sulle cause primarie (legate ad azioni da varare ad una scala superiore, dai veri inquinatori globali) gli interventi da mettere in campo non possono che limitarsi alla predisposizione di provvedimenti destinati al contenimento dei danni. Per porre un argine alle conseguenze locali del riscaldamento globale vengono quindi varate norme per la limitazione delle emissioni di gas serra e per la transizione verso la produzione di energia rinnovabile, imprescindibili per molte ragioni ma destinate ad un esito molto limitato e marginale, oltre a singoli provvedimenti a sostegno di quelle categorie di attività che subiscono i danni maggiori.
Ancor più pertinente al tema del titolo è il caso delle catene logistiche e delle politiche infrastrutturali. Dalla riapertura e dal potenziamento delle capacità di transito del Canale di Suez, il Mediterraneo è progressivamente divenuto uno dei più trafficati snodi dei flussi mondiali. È una enorme concentrazione di economie esterne che, ai fini della crescita economica dei Paesi rivieraschi, necessita della adozione di strategie complesse che si dipanano su tutti e tre i piani considerati: alla scala globale, a quella di teatro e, infine, al terzo livello di intervento, ossia alla scala locale o regionale (quella nella quale il rapporto di riduzione è inferiore a 1:3 milioni, ossia 1 cm sulla carta corrisponde fino ad un massimo di 3 milioni di cm reali).
La piccolissima scala è chiamata in causa in quanto la gran parte dei flussi che solcano le acque mediterranee hanno come origine o destinazione i porti della Cina e dei Paesi dell’Estremo Oriente. Si tratta di flussi globali enormi, che si sviluppano su decine di migliaia di km, sono in grado di muovere l’economia di interi Stati, in Europa hanno basi operative sia nei porti mediterranei sia in quelli atlantici, della cimosa europea Settentrionale che hanno la loro punta di diamante negli evoluti scali anseatici. Va da sé che i traffici mediterranei hanno una grandissima rilevanza economica per l’Italia, per i porti del Mezzogiorno in particolare, in quanto da essi potrebbero dipendere i destini economici del nostro meridione. A ben guardare, però, anche l’attività dei porti della Francia Mediterranea, della Grecia, della Spagna, della Croazia, dell’Africa Settentrionale, della Turchia, di Israele e degli altri Stati Mediorientali sono largamente interessati dal movimento di cabotaggio, ma soprattutto, dai grandi flussi provenienti dall’Estremo Oriente. I quali hanno nel canale di Suez, nello stretto di Bab el Mandeb e nel Mar Rosso un collo di bottiglia che, a volte, assomiglia tanto ad un nodo scorsoio. È sufficiente che una grande petroliera si metta di traverso nel percorrere il Canale di Suez, che orde di pirati somali o yemeniti -opportunamente armati e finanziati- assaltino navigli in transito, che gruppi ribelli di Yemeniti prendano di mira grandi portacontainer occidentali, per causare il dirottamento dei flussi dal Mar Rosso verso il periplo dell’Africa provocando un notevole scompiglio nelle economie dei Paesi mediterranei.
Probabilmente non è questo un obiettivo delle potenze globali, per ragioni economiche e geopolitiche che andrebbero esaminate. Certo, se delle vicende strategiche lo richiedessero, le due grandi potenze globali potrebbero agire indisturbate perché, sempre alla piccola scala, non troverebbero ostacoli alla realizzazione dei loro obiettivi. E la considerazione che ai traffici mediterranei siano interessati diversi Paesi della UE non ha stimolato quest’ultima a porsi concreti obiettivi di coordinamento e di difesa degli interessi dei propri aderenti. Ad esempio, per ragioni già esaminate, manca all’UE una forza militare propria in grado di proteggere il proprio naviglio e di fronteggiare con rapidità ed efficacia emergenze sulla via del Mar Rosso e del Canale di Suez. Fra l’altro, è proprio questo uno dei punti che penalizza l’azione della UE e che contribuisce ad escluderla dall’appartenenza alla cosiddetta scala globale.
Le ultime considerazioni consentono di rilevare come anche alla scala di teatro le valutazioni sulle visioni geopolitiche dell’UE non siano particolarmente brillanti. Certo, interesse primario della UE, in quanto unione di 27 Paesi e con un numero significativo di essi, direttamente o indirettamente, gravitanti sul mare nostrum, sarebbe la realizzazione di una pacificazione di tutta la regione mediterranea. Obiettivo che oggi fa sorridere, proprio per la sin troppo manifesta sproporzione fra la portata della visione strategica della UE e la sua reale capacità di intervento e l’effettiva, fuori scala, dimensione dei problemi sul campo. E fuori scala appare anche la qualità politica della dirigenza europea molto più focalizzata sulle tematiche domestiche piuttosto che ai grandi problemi globali e a quelli, non meno insidiosi, mediterranei.
Ma se sui temi militari e geopolitici il ruolo “mediterraneo” della UE non sembra possedere grandi capacità di proporre soluzioni, anche sul versante economico l’interesse sul mare nostrum appare secondario e non corroborato da una adeguata conoscenza delle reali potenzialità di crescita. Pochi confronti di natura demografica fra i Paesi Europei e gli Stati nordafricani e asiatici dovrebbero indurre a qualche attenta considerazione anche solo sul medio periodo, ma non sembra che questo capitolo venga effettivamente aperto. Inoltre, indipendentemente dalle particolari interferenze del conflitto russo-ucraino, anche l’approccio alle relazioni con i Paesi orientali (Russia, ma anche Asia Centrale e Caucaso meridionale) non ha rappresentato il frutto di una linea unitaria. Da un canto, infatti, continua a rimarcarsi l’atteggiamento scostante degli Stati dell’ex patto di Varsavia, dall’altro la diffusione degli accordi e delle relazioni bilaterali hanno fatto emergere la sostanziale inconsistenza, il fallimento, di una politica estera comune (emblematica, in proposito, la vicenda del North Stream). Per i Paesi europei situati a Oriente, l’adozione di una forte iniziativa centralizzata nella UE con l’obiettivo di una integrazione a Est, quindi verso i grandi produttori di petrolio, gas naturale e altri minerali pregiati, sarebbe la piattaforma per una convergenza di interessi nazionali su realizzazioni concrete. Comunque, allo stato, un obiettivo poco praticabile a causa del persistere del conflitto russo-ucraino.
Sulla, colpevole, scarsa propensione della UE di elaborare strategie mediterranee e africane, qualche considerazione meriterebbe il cosiddetto “Piano Mattei”. Elaborato da Palazzo Chigi e presentato dalla nostra Presidente del Consiglio dei Ministri, ha per oggetto l’insieme delle iniziative in atto da parte delle imprese italiane sull’intero continente africano. Argomento sin troppo importante per essere relegato in poche righe ma, in attesa di dedicargli maggiore spazio, non ci si può esimere da alcune valutazioni di sintesi. L’iniziativa è di grande pregio sul piano dell’intuizione politica, anche se a tuttora non sono stati ben collimati gli obiettivi da perseguire. Soffre, inoltre, di qualche velleitarismo, soprattutto per l’esiguità delle risorse messe in campo (5 miliardi: tanti per un Paese come l’Italia, pochi per un progetto così ambizioso, quantomeno nelle intenzioni). Di nuovo, l’iniziativa si presenta fortemente asimmetrica: un maggiore coerenza di scala sarebbe raggiungibile con un impegno e risorse UE e con l’Italia -in virtù dell’interesse concretamente palesato- al vertice dei programmi. Un buon compromesso ostacolato, però, dalla scarsa lungimiranza e visione strategica della geopolitica di casa nostra.
Ma è sui Paesi del corpo storico del Mec prima, quindi della Cee, che si misura la grande debolezza della UE nel campo logistico e la carenza strutturale della visione geopolitica. L’economia di questi Paesi, con il contorno delle nuove afferenze, è integrata su una forte propensione atlantica e una più che modesta gravitazione mediterranea. Non è questa la sede per analizzare le ragioni di questo dato di fatto: va solo rilevato come l’attuale portualità della UE non sia la conseguenza di una strategia economica o geopolitica, di un piano elaborato per raggiungere obiettivi condivisi. È solo il punto di arrivo di processi di crescita spontanei, guidati dalla sagacia e dalla capacità imprenditoriale dei manager portuali e degli interventi pubblici dei vari Stati.
Non è detto, però, che il continuo confronto fra i porti della cimosa settentrionale e quelli mediterranei costituisca un traguardo ottimale per la UE. Ad esempio, logica vorrebbe che, dal punto di vista del sistema-Europa, i due grandi versanti portuali, non entrassero in conflitto fra loro. Un piano europeo condiviso per l’organizzazione portuale, per le relazioni con l’avanmare, per la gestione dei flussi interni, certo scontenterebbe le strutture più forti. Potrebbe, però, depotenziare l’inutile concorrenza per la contesa del retroterra centro-europeo, per specializzare le destinazioni, per l’ottimizzazione, la digitalizzazione, dei servizi di sbarco e imbarco. Per evitare, ad esempio, che i porti della lega anseatica investano pesanti risorse per il potenziamento della portualità nordafricana con il solo scopo di sottrarre movimento ai porti europei del Mediterraneo. Una concorrenza non solo inutile, ma dannosa.
L’assoluta preponderanza dei porti atlantici (ad es. una parte consistente degli agenti di import-export di Milano ha maggiore convenienza a servirsi dei porti dell’Europa del Nord piuttosto che dei sistemi portuali mediterranei) premia certamente l’efficace attivismo del locale management portuale. Penalizza inutilmente, però, i porti del Mezzogiorno d’Italia i cui motivi della minore competitività risiedono certamente nella scarsa attenzione che i decisori pubblici italiani hanno riservato alla efficienza logistica di casa nostra, ma che un loro recupero competitivo consentirebbe minori percorrenze totali alle merci complessivamente movimentate. Questa situazione così dicotomica, di fatto colpisce pesantemente l’UE, ne ostacola la naturale proiezione mediterranea e ne allontana gli ingenti benefici che ad essa potrebbero derivare dalla adozione di un grafo dei trasporti se non ottimizzato, quantomeno sub-ottimale, e dalla gestione non competitiva dei flussi di beni e servizi provenienti dai Paesi del Medio ed Estremo Oriente e che transitano per il Canale di Suez. Va anche osservato che la modesta attenzione alla geopolitica mediterranea è anche la conseguenza del modesto presidio assicurato dalla politica italiana alle fasi istruttorie dei provvedimenti legislativi della UE. A cui si aggiunge la inadeguata attenzione prestata alla filiera logistica del nostro sistema-Paese.
La scala locale e le difficoltà della visione geopolitica italiana
Allorché si scende dall’analisi di tematiche mediterranee a quelle più propriamente italiane o regionali, ai problemi della crescita produttiva e dei ritmi di sviluppo dei diversi contesti territoriali italiani è ineluttabile finire per riproporre il secolare problema degli squilibri economici e sociali fra il Nord e il Sud Italia. Un tema, che in queste considerazioni di natura geopolitica, è opportuno non affrontare: non tanto per questioni di non pertinenza, l’argomento è pertinente. Quanto per l’enorme massa di studi, di ricerche, articoli, volumi che, sul tema, sono stati prodotti e che qualche valutazione espressa in queste righe non aggiungerebbe o toglierebbe alcunché. È sufficiente considerare quanto grandi siano le difficoltà presenti nella organizzazione del territorio centro-meridionale e delle sue vocazioni economiche in una chiave geopolitica, ossia a sostegno di una strategia che possa trovare forme di integrazione fra le regioni meridionali e il quadro produttivo mediterraneo. La questione è intricata, molto più di quanto suppongano le forze politiche che si sono susseguite alla guida del Paese. Uno dei temi più complessi da affrontare riguarda la proiezione internazionale di segmenti del tessuto produttivo delle regioni italiane, in quanto se l’industria della Pianura Padana e delle valli alpine è fortemente integrata con le evolute economie dei Paesi confinanti, soprattutto con la Germania, non altrettanto si può dire della componente mediterranea e delle sue potenzialità future.
L’interazione con i Paesi nordafricani e del Vicino Oriente, a parte i prodotti energetici per i quali la storia è molto diversa, è resa difficile per una nutrita serie di ragioni. Innanzi tutto, per la presenza di differenti contesti culturali e quindi per la diversa sensibilità nei confronti dei problemi da affrontare per promuovere forme di collaborazione. Poi, e senza farne l’elenco, a causa dei ripetuti, numerosi, episodi di grave instabilità politica nel Mediterraneo Centrale e Orientale: non si può sottacere che la convivenza fra i Paesi che si affacciano sul mare nostrum è particolarmente difficile. Insiste poi una ragione decisiva: il tessuto produttivo di molte delle regioni mediterranee è sostanzialmente analogo a quello del Mezzogiorno, e quindi non di integrazione si parla, bensì di competizione. Agricoltura, allevamento, turismo, commercio sono, quasi ovunque, capitoli ricorrenti nella costruzione dell’ossatura economica dei Paesi Mediterranei. Difficile, se non impossibile, avviare forme di integrazione economica in grado di trainare il tessuto produttivo delle nostre regioni, se tutti puntano ad avere l’Italia e l’Europa come principale mercato di sbocco.
Negli anni, alcuni Paesi dell’area balcanica e dell’Africa Settentrionale hanno ospitato stabilimenti industriali in un contesto di delocalizzazione di segmenti del ciclo tecnico di produzione alla ricerca di minori costi della manodopera. L’esperienza, però, è andata perdendo di importanza, senza lasciare grandi seguiti. In questa difficoltà di trovare vere forme di interazione funzionale, tradizionale o evoluta che sia, la soluzione da perseguire dovrebbe privilegiare l’ammodernamento del territorio meridionale e insulare, la ricerca della competitività territoriale, l’infrastrutturazione del Mezzogiorno, la creazione delle basi formative per l’innovazione tecnologica, la rete di hub per l’efficientamento dei trasporti.
La modernizzazione del territorio meridionale e la competitività dei suoi hub logistici rappresentano comunque uno dei principali punti di attacco per costruire un assetto produttivo connesso all’interno e proiettato verso i mercati mediterranei e di tutto l’Oriente, anche con un salto di scala. Su questi obiettivi il cammino è comunque lungo e, accanto all’adeguamento agli standard internazionali delle catene logistiche centro-meridionali, dei principali sistemi portuali delle regioni meridionali, va radicalmente ripensato, ma è solo uno degli esempi possibili, il collegamento fra le strutture portuali e il loro naturale retroterra. Un porto scollegato dalla propria area di gravitazione è un’isola in mezzo ad un mare, connesso ad una astratta rete sovraregionale, quando non sovranazionale. Ce lo ricordano i porti industriali della Sicilia. Costruiti sui grandi impianti per la raffinazione, Gela, Milazzo, in parte Priolo, a causa dell’assenza di infrastrutture per i trasporti che dal porto raggiungessero i principali poli della Sicilia e del continente, sono rimasti del tutto estranei al tessuto economico locale. Paradossalmente l’integrazione degli impianti di raffinazione avveniva e avviene nel contesto della filiera dell’approvvigionamento energetica e quindi con le grandi aree industriali dell’Italia settentrionale e del Nord Europa. Non dissimili le vicende del porto di Gioia Tauro che con un movimento complessivo dell’ordine di tre milioni di TEU è un porto container di elevata competitività. Il suo unico problema è che trattasi di un hub di transhipment, un porto ove avviene il trasbordo dalle portacontainer oceaniche al naviglio di cabotaggio per raggiungere le destinazioni finali. Grande movimento portuale ma irrisorie ricadute sul territorio.
Qualche breve considerazione per concludere
Da quanto emerge nel testo che precede, va preso atto che la geopolitica e la geoeconomia sono entrate pesantemente nell’orientare le strategie dei Paesi europei, dell’UE, dell’Italia. Non poteva essere diversamente, a causa della grande spinta data alla globalizzazione dei mercati nei decenni appena trascorsi e con questa nuova situazione internazionale è oramai necessario fare i conti. Ciò richiede una notevole preparazione, ma una sensazione molto insidiosa riguarda le capacità politiche ed economiche espresse dalla classe politica uscita dalle votazioni europee che nel complesso appare non del tutto attrezzata di quelle qualità, di quelle conoscenze indispensabili per misurarsi con problemi anche molto complessi. Non si può generalizzare e le sensazioni contano per quello che valgono: nulla. Ma la sensazione rimane. Inoltre, è una teoria dello scrivente, non condivisa da molti esponenti delle istituzioni italiane ed europee, ma uno dei problemi all’origine di tante difficoltà è la legge elettorale, che andrebbe pesantemente rivisitata. Non tanto nel senso di preferire una maggiore o minore incidenza del maggioritario piuttosto che del proporzionale, quanto di regole spicce come l’obbligo dei candidati vincitori di assumersi la responsabilità di un seggio, il divieto di candidature su più collegi: togliere quella idea che i segretari di partito possano intervenire sulle scelte dell’elettorato.
Un secondo momento di grande fragilità è costituito dalla modestissima conoscenza diffusa della geopolitica e della geoeconomia. In un Mondo sempre più connesso e integrato è indispensabile possedere solide basi conoscitive mentre, sin dall’istruzione universitaria, si manifestano grandi carenze sui saperi in quanto, ad esempio, queste materie non sono curricolari. In politica, come in economia, non c’è spazio per il principio del learn by doing.
Il terzo fattore di vulnerabilità sistemica è dato dalla demografia. L’Europa, e l’Italia in particolare, hanno una popolazione anziana e in declino. Il tasso di fertilità femminile suggerisce, per i prossimi decenni, un ulteriore calo nelle nascite. Ne consegue una perdita di popolazione e un progressivo, costante, invecchiamento della popolazione residente. Quarto e, per ora, ultimo elemento di criticità è rappresentato dalla UE, dalla sua conformazione attuale. Ancor oggi è un edificio mirabile, purtroppo largamente da completare e con l’inspiegabile contrarietà di diverse forze politiche. Se i cittadini europei desiderano contare qualcosa nel mondo la vera strada da percorrere è dare contenuti e forza alla UE. La mia speranza personale è di aver speso alcune considerazioni a favore della individuazione di una linea ragionevole di comportamento e che quanti hanno avuto la pazienza e la determinazione di arrivare in fondo a queste righe ne possano trarre le giuste conclusioni.
Tags: Africa Cina Europa Italia USA