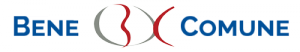In realtà, la responsabilità di quello che l’Istituto Cattaneo ha definito un “clamoroso astensionismo” è riconducibile a più fattori, alcuni di tipo strutturale in quanto ricorrenti in ogni consultazione; altri contingenti, legati cioè allo specifico tipo di elezione. I primi sono sicuramente in crescita – anche a causa del progressivo invecchiamento demografico che rende più difficile l’esercizio del diritto di voto per una quota sempre crescente di popolazione – ed interessano tutte le democrazie occidentali.
Tra i secondi, in questa particolare occasione, hanno pesato le numerose inchieste giudiziarie che hanno coinvolto le regioni; il malessere sociale, alimentato dall’emergenza di una crisi economica dalla quale il Paese fatica ad uscire; l’opinione diffusa che il Pd avrebbe vinto; l’assenza di candidati “forti” e, non da ultimo, anche il semplice fatto che si sia votato un solo giorno anziché in due. È la combinazione di tutti questi fattori, accompagnata da un cambiamento della cultura politica per la quale il voto è sempre meno un dovere e sempre più un diritto da esercitare secondo le circostanze, ad aver allontanato gli elettori dalle urne o, quantomeno, a non averli spinti ad esprimere con il proprio voto un’appartenenza, un’identità.
Le tornate elettorali di questi ultimi anni ci dimostrano che un numero sempre crescente di voti è “mobile” e che il rapporto tra elettori e partiti non è più il riflesso di un’identità e, quindi, un punto di riferimento fisso. Pertanto parlare tout court di crisi dei partiti non è corretto. La crisi esiste, ma investe un preciso modello di partito: il partito di massa che per quasi un secolo ha plasmato la forma idealtipica dell’organizzazione politica nelle democrazie rappresentative.
È vero, non esistono più i partiti che accompagnano l’elettore/militante dalla culla alla tomba, ma questo non basta a decretarne la morte. Anzi, mai come oggi i partiti conservano un ruolo primario sia nella definizione dell’agenda politica che nella selezione del proprio personale politico e possono contare su una considerevole quantità di risorse finanziarie. Se di crisi si può parlare, dunque, questa è un’innegabile crisi di legittimità e di credibilità, come dimostrano i bassi livelli di consenso nei confronti dei partiti e delle istituzioni (nel 2013 la fiducia verso i partiti politici, su una scala da zero a dieci, è stata in media pari ad appena 2,2; Istat 2014).
Continuare a discutere sulla fine dei partiti avendo in mente un preciso modello di riferimento, per l’appunto il partito d’integrazione di massa, è fuorviante. L’attualità politica ci dice che i partiti hanno semplicemente cambiato “forma”. L’evoluzione dei partiti contemporanei sembra orientarsi verso il modello britannico della “grande tenda” (big tent), del partito “piglia-tutti” (catch all party), o ancora “partito della nazione”: l’obiettivo del partito politico non è quello di dare un’identità e un’appartenenza ad un gruppo originario di riferimento, ma quello attrarre interessi e valori trasversali, rendendosi appetibile a quanti più elettori è possibile.
Nello stesso partito possono confluire più punti di vista senza che gli elettori condividano necessariamente la stessa visione del mondo. In tale prospettiva, ogni appuntamento elettorale diviene una competizione aperta nella quale conquistare di volta in volta gli elettori, convincendoli a votare un programma, un’idea, un candidato o molto più semplicemente ad andare votare. Di conseguenza, anche il non-voto è una scelta e non per forza una stortura dei sistemi democratici. Specularmente, il calo degli iscritti al partito non implica una perdita dei consensi.
In altre parole, i partiti sono passati da una politica dell’offerta (di valori, di ideologie, d’identità) a una politica della domanda, dove la competizione elettorale è determinata dalla capacità di dare o meno una risposta politica alle istanze collettive. Non è quindi del tutto vero che l’interesse per la politica e la partecipazione sono venuti meno; piuttosto se ne sono modificati gli spazi e i meccanismi. Ciò è stato ben compreso dai movimenti populistici che, liquidati con troppa facilità come antipolitica, si rafforzano e si diffondono proprio al crescere dell’insoddisfazione nei confronti del sistema dei partiti.
Semmai, il problema della nuova ondata populista è quello dell’eccessiva semplificazione politica, che postula un’equivalenza tra buona politica e politica facile, senza cioè compromessi e mediazioni tra interessi contrastanti. In proposito è fondamentale tener presente che una cattiva/inadeguata offerta politica non è indipendente da una cattiva domanda; una cattiva domanda che nasce da un’evoluzione sociale in cui le istituzioni e i corpi intermedi hanno perso il radicamento con la società civile, con gli interessi e con i bisogni reali del Paese.
La vera sfida per i partiti, così come per tutti i corpi intermedi, è allora quella di tornare ad essere le cinghie di trasmissione tra i cittadini e le istituzioni, tra la domanda e l’offerta politica. Organizzare e strutturare l’incontro tra domanda e offerta politica, pensando forme, spazi e procedure di civismo organizzato realmente partecipativi, è quanto mai vitale per chi si candida a un ruolo di rappresentanza. Difatti, solo decisioni di qualità, in quanto coerenti con le aspettative degli elettori e condivise in un rapporto di scambio costante, possono preservare da rovinose cadute.
Un ragionamento sulla mutazione in atto dei partiti politici, finora incontrastati protagonisti della nostra democrazia, non può infine prescindere dai limiti connaturati alla struttura che si sono dati e che li ha portati ad una clamorosa crisi di fiducia. Tale limite è insito nel concetto di poliarchia che – ripreso nell’enciclica di Papa Ratzinger “Caritas in Veritate” – contempla una divisione sociale dei poteri capaci di sviluppare in modo operoso il pluralismo e il bene comune, riscrivendo la grammatica della sussidiarietà. Difatti, in un sistema poliarchico si valorizza la funzione di reciproca limitazione che ciascun potere sociale svolge rispetto a tutti gli altri e le formazioni sociali assumono responsabilità pubbliche con una valenza pari ai soggetti istituzionali che non godono più di alcun primato.
Del resto, in una società come quella contemporanea i vari interessi difficilmente possono essere rappresentati in forma monolitica e da un solo corpo intermedio: tutti i soggetti sociali devono poter acquisire e condividere in modo paritario meccanismi e procedure di reciproca legittimazione e interazione sul versante programmatico, decisionale e regolativo. Questo significa che i partiti sono ancora funzionali alla costruzione di una politica nazionale, contribuendo attraverso le candidature alla selezione della classe dirigente, ma non rivestono più un ruolo esclusivo.