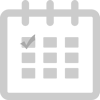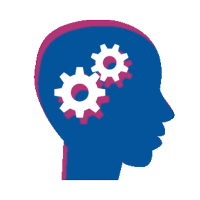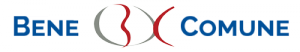Il tema astensionismo è entrato da tempo nell’agenda politica e nel dibattito pubblico del nostro paese. Se in passato – e ci riferiamo ai decenni che vanno dal dopoguerra sino alla fine degli anni settanta – una sorta di obbligo morale vincolava i cittadini ai partiti e quindi alle urne, al giorno d’oggi la decisione di non votare è stata ormai sdoganata come espressione legittima, al pari delle altre, delle proprie convinzioni politiche, sino al punto da interessare la maggioranza relativa (se non assoluta) degli elettori. I dati parlano chiaro: 25% di astenuti alle elezioni politiche del 2013, oltre il 40% alle elezioni europee del 2014 e circa il 50% alle elezioni regionali del 2015, non considerando le tornate di voto locali precedenti e successive a queste date in cui il non voto ha raggiunto picchi anche superiori. In presenza di un fenomeno quasi costantemente in crescita e dagli effetti potenzialmente devastanti per la tenuta della democrazia, gli studiosi si interrogano da tempo su alcune questioni chiave: da chi è composto il popolo di chi non vota? In cosa si differenzia da chi va invece a votare? Cosa spinge una parte importante dell’elettorato a disertare le urne? E, soprattutto, quale cambiamento sarebbe necessario per invertire il trend di disaffezione?
Proviamo ad affrontare questi nodi partendo da alcune questioni chiave che riguardano il profilo – demografico, sociale, politico – di chi si astiene. E’ possibile identificare un popolo degli astenuti? Esiste un partito di chi si astiene? In entrambi i casi la risposta è evidentemente negativa. Dentro la galassia del non voto si concentra una popolazione fortemente diversificata, la cui disomogeneità è aumentata nel corso del tempo in ragione di fenomeni più generali – su tutti la crisi economica – che hanno messo in discussione la tenuta dei governi, la loro capacità di intervento e, quindi, l’efficacia stessa del voto.
Se si ripercorre la storia della partecipazione (e della disaffezione) elettorale in Italia emergono almeno due fasi piuttosto distinte, a cui va aggiunta una fase più recente dagli esiti incerti. Le prime interpretazioni del non voto, all’inizio degli anni ’90, si soffermavano sull’apatia dell’elettorato astensionista, la cui esclusione veniva attribuita sostanzialmente alla bassa dotazione di risorse, alla perifericità sociale ed economica, alla distanza dai luoghi della politica. In buona sostanza, il non voto veniva letto come un fenomeno fisiologico riconducibile alla presenza di una fascia di cittadini che disponevano di pochi strumenti, relazioni e capacità cognitive da spendere sulla scena politica; quindi, soprattutto, donne, anziani, persone con basso titolo di studio, residenti nelle aree isolate del paese.
La novità stava nel fatto che, a seguito del crollo della Prima repubblica, erano venute meno anche le ragioni che in passato vincolavano alla politica queste categorie sociali meno attrezzate e motivate a partecipare. La fine dei partiti di massa aveva prodotto un indebolimento degli stimoli, della presenza sul territorio, dei canali di identificazione prima (o anche) sociali che politici che avevano permesso a (quasi) tutti di compiere il semplice atto di andare a votare. Questa connotazione specifica degli astenuti spiega anche perché non si ritrova al loro interno, almeno fino alla fine degli anni ’90, un deposito di voti riconducibili alla sinistra o alla destra.
A questa fotografia del non voto se n’è aggiunta, nel corso del tempo, un’altra di pari importanza, in cui compare un tipo di elettore diverso: politicamente strutturato, socialmente integrato, che protesta perché insoddisfatto e che usa consapevolmente lo strumento del ritiro del consenso per manifestare la sua insoddisfazione e colpire i partiti di riferimento. All’apatia si aggiunge la protesta, che sottende un sostrato di alienazione, estraneità e convinzioni negative nei confronti della politica. All’incapacità di decidere («non so cosa votare, e non c’è nessuno che me lo dice»), si sovrappone la scelta di non attivarsi, la negazione volontaria del consenso («potrei votare ma ho deciso di non farlo»), da parte di cittadini che non si riconoscono nei partiti e non trovano nella politica ufficiale delle risposte tali da motivarli ad andare a votare. Dal punto di vista del profilo socio-politico questa discontinuità ha favorito una “normalizzazione” dei non votanti: non più (non solo) periferia del paese e della società, ma localizzati anche al centro (nelle grandi città del Nord Italia sino alla zona “rossa” storicamente civica e allineata, all’interno del mondo del lavoro). A smobilitarsi sono (anche) quelli che valutano la politica sulla base di standard più elevati e sviluppano un orientamento critico che li porta a cambiare preferenza partitica oppure ad astenersi.
Le indagini elettorali ci dicono che questa area è in crescita. Uno degli indicatori chiave è l’avanzamento dell’astensionismo intermittente, ossia della quota di quelli che entrano ed escono dalla scena elettorale alternando voto e non voto. La presenza degli intermittenti porta, evidentemente, a ripensare il concetto di partecipazione e l’idea stessa di distinzione tra votanti e non votanti. Se, per un verso, non è possibile cristallizzare gli astenuti in un partito, al contempo il non voto finisce per assumere un significato fortemente politico. La smobilitazione selettiva diventa, infatti, l’arma con cui una parte dell’elettorato solitamente fedele punisce, a seconda delle circostanze, una delle forze in campo condizionando l’esito delle elezioni. E non è un caso che i partiti, in campagna elettorale, puntino sempre più a contendersi il «mercato» degli elettori potenziali e a frenare la fuga dei propri elettori.
Ma veniamo alle nuove sfide che pone l’astensione. La doppia crisi, economica e politica, dell’ultimo decennio ha prodotto un’accelerazione di alcune dinamiche già presenti da tempo nel nostro paese. Da un lato si sono allargate le disuguaglianze economiche e territoriali. Il peggioramento delle condizioni lavorative e di reddito per una parte della popolazione ha amplificato la percezione di insicurezza e frustrazione, in presenza di governi nazionali che mostrano una minore capacità di tutelare gli interessi dei cittadini rispetto a istituzioni sovra-nazionali lontane, poco controllabili e identificabili. Al contempo, il quadro politico ha subito una repentina trasformazione, con la successione dal 2011 di governi tecnici e politici, l’emergere di nuove leadership e di un partito anti-establishment come il Movimento 5 stelle. Ogni tentativo di cogliere le caratteristiche e l’evoluzione dell’astensionismo oggi non può prescindere dal fatto che un’opzione di voice radicale si è aggiunta alla possibilità di exit, canalizzando una parte della disaffezione, rendendo più ampio il ventaglio di scelte dell’elettorato distaccato o arrabbiato. Mentre è cresciuta ulteriormente l’insoddisfazione verso la politica, i suoi attori e le sue istituzioni, si è aperto uno spazio nuovo di offerta partitica capace di alimentarsi dello stesso processo di delegittimazione.
L’alternativa tra astensione e voto di rottura si pone, innanzitutto, per quella fascia di elettori impoveriti e senza diritti, che trovano particolarmente invitante la scorciatoia populista o perdono definitivamente il contatto con la politica ufficiale. Riguarda, però, anche le nuove aree dell’esclusione – una parte del mondo giovanile e dello stesso lavoro dipendente roccaforte dei partiti di massa – che vivono con maggiore consapevolezza lo squilibrio tra aspettative di realizzazione (alimentate spesso da livelli elevati di istruzione) e intrappolamento dentro status socio-professionali subalterni.
Alla fine di questa riflessione ha senso chiedersi quale sia la chiave – se esiste – per arginare il fenomeno astensionista. Una decisione importante, da parte della politica, potrebbe essere quella di concentrare l’attenzione sulle nuove generazioni di elettori. I giovani nel nostro paese contano poco perché sono sempre meno numerosi. Non stupisce, quindi, che lo squilibrio demografico si rifletta sull’agenda dei governi, raramente propensi a impegnarsi a favore di questa componente debole e poco rappresentata dell’elettorato. Per invertire la spirale di delegittimazione che colpisce anche i giovani si potrebbe agire sulle percezioni che essi hanno del mondo politico ufficiale e della possibilità di cambiarlo. Come? Ad esempio, offrendo esperienze positive di conoscenza, fiducia e riconoscimento nel rapporto con il mondo istituzionale.
Per ricucire la distanza con i giovani, alla politica ufficiale non basta esibire strumentalmente parole vuote come ringiovanimento e innovazione. Prima ancora di scegliere da chi farsi rappresentare, i giovani hanno bisogno di sperimentare modalità diverse di interazione con i partiti. La partecipazione non può avvenire all’interno di contenitori vuoti e secondo logiche esclusivamente procedurali o cooptative, ma deve riuscire a produrre effetti reali favorendo processi autonomi di emersione della consapevolezza politica nei luoghi, sui temi e con le modalità più prossimi ai giovani.
Tags: astensionismo giovani e partecipazione